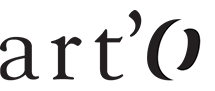Il rito segreto delle Baccanti. Simone Derai all’Olimpico di Vicenza
Entrano da un lato percorrendo tutta la balconata che si affaccia sulla scena del teatro Olimpico, a Vicenza. Vestite tutte uguali, una lunga gonna grigia sotto una maglietta nera sbracciata. Ciascuna con una coperta ripiegata sulle braccia. Che siano corpi maschili o femminili non fa differenza. Sono le Baccanti che su questa scena si apprestano a celebrare il loro rito, come l’ha pensato Simone Derai per il 78° Ciclo di spettacoli classici. È la seconda stagione diretta da Ermanna Montanari e Marco Martinelli all’insegna del Coro, simbolo di un comune sentire che forse la polis ha perso e tocca a loro, a noi forse, segretamente far rivivere. Quando la raggiungono, giù nello spazio fisico a loro deputato, si dispongono in cerchio lungo il perimetro luminoso tracciato al suolo. Poi uno di loro viene spinto in avanti, verso il centro.

Eccomi, sono qui. Sono arrivato – sono le prime parole che pronuncia chi ha assunto su di sé il ruolo di Dioniso, il dio tornato a Tebe per ripristinare il suo culto. Si racconta che così abbia avuto origine il teatro, nell’antica Grecia del VI secolo a.C., quando un singolo attore si stacca dal coro danzante e comincia a dialogare con quello. È questa la nascita della tragedia. Ma qui siamo piuttosto alla fine della forma tragica. Baccanti è l’ultima tragedia scritta da Euripide, pochi mesi prima della morte nel 406 a. C. Pochi decenni sono passati dal tempo di Eschilo, e il dramma di Euripide segna forse il momento più alto ma anche la fine irreversibile della grande invenzione della Grecia del quinto secolo. Giacché Baccanti è tragedia che non lascia scampo. Un senso di precarietà assoluta è ciò che lascia al termine. E se Eschilo, mezzo secolo prima, aveva raccontato attraverso le vicende dell’Orestea la nascita della democrazia ateniese, attraverso l’invenzione del tribunale democratico, a Euripide tocca raccontare la fine della polis – fine anche politica, travolta dalla guerra del Peloponneso.

La divinità è scesa sulla terra. Si mescola agli uomini. Vuole farsi riconoscere, chiede il tributo rituale dovuto. In passato Dioniso ha portato doni all’umanità, ora porta la violenza delle donne che celebrano i suoi riti, che avanzano scarmigliate e armate di bastoni. E Penteo che rifiuta la nuova religione venuta da Oriente e sceglie la via repressiva alla razionalità ne sarà travolto, costretto alla vergogna di travestirsi da donna e in tale veste fatto a pezzi dalla madre invasata, in un finale di insostenibile violenza.
Sulla scena sono rimaste solo rovine e con quelle bisogna fare i conti. In quel vuoto bisogna cercare ragione e umanità. Ma oggi? È possibile raccontare ancora quella storia lontana nel tempo senza interrogarsi sul suo senso politico nel presente? Nel fallimento politico del presente, bisognerebbe forse dire. Siete vecchi – dice Penteo, il capo del governo, a Cadmo e Tiresia che si interrogano sul che fare di fronte alla sovversione prodotta dalle donne possedute dal dio. Ma anche lui perderà la testa, letteralmente.
Simone Derai ha scelto di trasformare il racconto in un palpitante rito notturno messo in scena dai giovani attori che vestono i panni delle Baccanti. Sono i dieci allievi dell’Accademia teatrale dello Stabile del Veneto con cui ha lavorato nell’ultimo anno e che produce lo spettacolo. Mettendo in atto dunque un doppio salto concettuale, che nega la rappresentazione e la stessa presenza dei personaggi al suo interno, giacché tutto si gioca fra gli attori e quel coro a cui danno vita. Danzano, cantano come in trance; si abbandonano a scene di possessione al ritmo ipnotico delle musiche di Mauro Martinuz. Si appoggiano alle pertiche che hanno raccolto da terra e richiamano certo il tirso rituale delle Baccanti, ma viene in mente anche il bastone che Joseph Beuys utilizzava nelle sue performance per simboleggiare la trasmissione dell’energia tra l’uomo e la terra.

Facendo tesoro delle ferree limitazioni sceniche poste dall’Olimpico, e tuttavia lasciando emergere dal buio la sua meraviglia quando serve, il regista di Anagoor limita gli oggetti scenici a quelle coperte vestite a volte come mantelli, ai teli dai bagliori dorati che possono essere simbolo di regalità o evocare i sacchi che raccolgono i corpi dei morti per mare. Quando la morte verrà come l’orso affamato in autunno. Oppure: non devi essere buono. Non devi trascinarti in ginocchio – dicono i versi di Mary Oliver che contagiano la traduzione di Davide Susanetti. Se possa essere anche curativa questa pratica magica che forse è rito di iniziazione, come vorrebbe l’artefice, non saprei dire. Ma qualcosa di più sul nostro ruolo all’interno della comunità che così si è formata, un po’ l’abbiamo capito all’uscita da questo bellissimo spettacolo. Baccanti è una visione apparsa a un coro di cui per una sera siamo diventati parte. Non solo le vittime dell’illusione teatrale. Quando il teatro è felicità, si diceva altre volte.
© Gianni Manzella