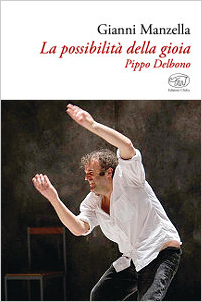-
Robert Wilson e L’affare Makropulos
Non ha il respiro del grande spettacolo, come la Lulu vista l’autunno scorso a Parigi, L’affare Makropulos realizzato da Robert Wilson con gli attori del Teatro nazionale di Praga. C’è fra le due creazioni, si potrebbe dire, la stessa distanza che corre fra il capolavoro di Wedekind e il dramma posteriore di un paio di decenni di Karel Čapek (che però aveva tentato anche Luca Ronconi in altri tempi). Una questione di misura, piuttosto che di stile – sembra infatti ritagliato apposta per il palcoscenico del settecentesco teatro Mercadante, dove è andato in scena per il Napoli teatro festival.
Eclettico nelle scelte, insaziabile nel moltiplicare le occasioni produttive, il regista texano è tuttavia fra i più rigorosi nel preservare la propria maniera. Qui la mette al servizio di una vecchia attrice della scena boema, l’ottantenne Soňa Červená, e di una tradizione teatrale apparentemente distante. Ma è difficile non vedere gli elementi di contiguità fra i due lavori, che pescano infatti in una medesima zona o un medesimo immaginario figurativo, fra espressionismo e cinema muto.
Non a caso anche qui il livido varietà si apre con la sfilata dei personaggi davanti al sipario nero su cui si illuminano in una miriade di combinazioni le due lettere iniziali dei molti nomi della protagonista, Emilia Marty è solo l’ultima delle sue incarnazioni. Marionette ingessate dentro costumi inamidati che richiamano gli inizi del secolo scorso ma tinti in colori acidi (uno giallognolo, l’altro violaceo…) che escludono ogni tentazione naturalistica, del resto negata in partenza nel teatro formale di Wilson. Si arrestano per un attimo, si voltano con un ghigno della faccia imbiancata verso gli spettatori. Dopo un po’ pare già di conoscerli tutti.
Lei invece entra da sola, come si addice al suo ruolo di regina della scena, è una cantante lirica dopo tutto. Caschetto di capelli fulvi e lungo abito nero tempestato di brillantini. A metà fra l’ultima Marlene Dietrich e la Crudelia del film d’animazione Disney, sarà per quel che di demoniaco che emana il personaggio e però non è possibile prendere sul serio. Circola infatti attraverso lo spettacolo un’aria di balletto meccanico o di opera dei pupi, una clownerie circense spinta fino alla comica slapstick, centrifugate in un sussulto della morente postmodernità siglato dall’innesto, in mezzo alle musiche, delle note pucciniane che dicono “un bel dì vedremo”.A dare il tempo è però un presentatore o maestro di cerimonia altissimo e magro nel cappotto dalle lunghe falde svolazzanti. È lui che, armato di bastone, dà il la ai tre musicisti che stanno infossati nella buca dell’orchestra o descrive meticolosamente scenografie che naturalmente non vedremo. Al sollevarsi del sipario appaiono quei fondali dai colori cangianti che fanno tanto Wilson. Pochi oggetti si aggettano dal palco nel vuoto programmatico della scena. Pile di fascicoli che lentamente crescono di altezza e si moltiplicano fino a disegnare una skyline di scartoffie burocratiche. Una foresta di tralicci o impalcature che inglobano anche scale e sedute. Dove si osserva soprattutto il continuo su e giù degli interpreti che emergono rigidi da invisibili botole.
Qui si compie la parabola della tricentenaria avventuriera che grazie a un elisir ha attraversato secoli e paesi, e incrociato le vite di tanti, cambiando identità ma non di gender a differenza del quasi coetaneo Orlando di Virginia Woolf. Eccola infatti fra ex amanti o loro discendenti e inconsapevoli pronipoti, intenti a disputare una quasi altrettanto longeva causa giudiziaria per una eredità di cui lei sa tutto, fra le cui carte c’è anche la formula della magica pozione. Di cui lei vorrebbe tornare nuovamente in possesso, malgrado il disgusto che prova per una vita troppo lunga. E a chi le chiede perché allora, lei risponde: perché ho paura di morire.
È questo il nucleo concettuale o ideologico, per così dire, de L’affare Makropulos. Che insomma a quel sogno di vita senza fine è bene non pensare, per quanto sia brutto invecchiare, che infatti subito suscita idee di superiorità razziale e desideri di potere. E allora un fuoco e via, ci pensa la più giovane dei presenti a distruggere la formula. La favola è finita. Il finale in musica ce lo conferma.
Articoli correlati