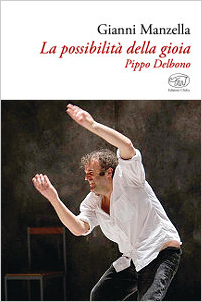-
La tradizione è vita che continua. Incontro con Toni Servillo
Voglio iniziare la nostra conversazione partendo dall’idea di tradizione: nel suo lavoro confluiscono due tradizioni importanti della storia culturale italiana, non soltanto due tradizioni teatrali ma anche due tradizioni sociali del teatro, se così si può dire. Da un lato la tradizione del teatro napoletano, una cultura che non è soltanto una pratica scenica ma riverbera anche in un modo di andare a teatro, di guardare il teatro all’interno di un continuum di una realtà sociale precisa. Dall’altro la tradizione del ‘nuovo’, quella della ricerca teatrale degli anni Sessanta, anche quella radicata in un modus vivendi, in un ‘essere sociale’ del teatrante che accompagna la sua pratica artistica. Oltre a questa tradizione ‘accolta’, mi domando in che termini il suo lavoro, a partire dagli anni Settanta, poi con l’esperienza di Teatri Uniti nel teatro e nel cinema, costruisce una ‘tradizione’ per le generazioni future.
Quando si usa la parola ‘tradizione’ – una parola che, come tante altre parole oggi, è soggetta a una confusione, a equivoci, quando non anche contrabbandata, prostituita di significati – io ricorro a una definizione che mi è molto cara, quella di Eduardo De Filippo: per Eduardo la tradizione è “la vita che continua”. E’ una definizione così poco demagogica, così poco intellettualistica, così profondamente vera e naturale. Nel senso che fa riverberare tanti significati autentici di questa parola: il primo che mi viene in mente è ‘trasmissione’. Il teatro è un’arte che trasmette pensieri, pratiche, comportamenti, riflessioni, emozioni, linguaggi, ma li trasmette perché il palcoscenico è una zona di passaggio, dove passa una corrente, passa un’energia di cui si carica una compagnia, un’artista, un’equipe di attori; e che poi trasmette alla platea e, a sua volta, la trasmette nelle forme del vivere sociale. Quindi la relazione con la tradizione – se è “vita che continua” – significa muoversi nei confronti del passato con un atteggiamento vitale, che è dettato da una curiosità, una curiosità onnivora, che guarda in tutte le direzioni, senza paraocchi: le forme d’arte, di teatro, di spettacolo che ti hanno preceduto. Se la tradizione è viva, guarda al futuro con uno slancio, che parte dalla conoscenza di quello che ti ha preceduto, che non necessariamente – e qui sta l’equivoco di questa parola – è qualche cosa che ti lega; può essere invece qualcosa che funge da trampolino, da slancio, da incoraggiamento.
Questo atteggiamento è quello che io sento caro nei confronti di questa parola. Tanto è vero che io ho individuato questo atteggiamento vivo verso la tradizione in due riferimenti a un passato recentissimo della nostra scena: Leo De Berardinis da un lato e Carlo Cecchi dall’altro. Due attori con cui ho avuto anche la fortuna di lavorare, che mi trasmettevano la tradizione che li aveva preceduti, con un linguaggio originale, una sensibilità moderna, un gusto personale. Tutti e due, però, essendo andati a bagnare i panni nel mare della cultura napoletana, chi in un modo chi nell’altro, sono stati una cultura vivente che nel segno di una tradizione rinnovata è arrivata fino a me.
In questo senso penso che il lavoro di Teatri Uniti possa costituire per il futuro una forma di tradizione. Penso alla nostra struttura come teatro, a ciò che rappresenta per i giovani: noi siamo qui in una sala del Teatro Valle, dove rappresentiamo per il terzo anno consecutivo la Trilogia della Villeggiatura, con un cast di quindici attori di cui almeno sette o otto al debutto di questo spettacolo erano sotto i trent’anni; e non ricoprono ruoli secondari, sono in ruoli di protagonisti.
Per quanto riguarda il cinema è lo stesso. Non affidiamo il nostro lavoro all’ecletticità di qualcuno che esprime qualcosa che gli è necessario in quel particolare momento della sua vita o, peggio ancora, a una forma di generica espressione di se stessi. Piuttosto tentiamo di costruire una struttura che sia un riferimento per i giovani nel cinema e nel teatro, non soltanto per quanto riguarda la recitazione, la regia o le arti che contribuiscono alla messa a punto dello spettacolo, ma anche in termini produttivi. Questo è il portato di un linguaggio, di un modo di lavorare con gli attori, di un modo di scegliere i temi, di un modo di produrre, un modo di distribuire, di scegliere i compagni di strada, di decidere di stare nel pubblico anziché nel privato. Nonostante siano venticinque anni che lavoriamo insieme e molti avrebbero potuto decidere di fare una scelta che va decisamente in direzione del privato, con tutte le conseguenze del caso. Noi invece restiamo fedeli a un teatro che sta nel pubblico con un certo tipo di sacrificio.
La trasmissione è oggetto di discussione, di strategia? Pensate al futuro di quest’esperienza?
Io so che soprattutto nei confronti degli attori più giovani che lavorano con me pongo dei problemi di interpretazione, non soltanto di un personaggio, ma di un testo, di un classico, della battuta, di come io penso che debba essere. E questo non è più una cosa tanto praticata sui nostri palcoscenici. Lo faccio con un atteggiamento veramente pedagogico, che lanci un ponte verso il futuro. Perché spesso oggi c’è uno strazio dei testi, utilizzati per il narcisismo quando non per la mera soddisfazione esibitoria di qualche artista – e dunque le intenzioni dell’autore sono completamente non trasmesse. Ma pongo dei problemi anche rispetto al governare un personaggio: è un lavoro che io non faccio nei seminari, perché non mi piace vivere di seminari e non ne ho la vocazione, ma lo faccio nel lavoro con la compagnia.
Finora abbiamo parlato di una tradizione teatrale accolta e costruita. Pensavo però anche a una tradizione cinematografica: il suo lavoro interseca un momento in cui il cinema italiano è riemerso all’attenzione internazionale dopo anni in cui si era smarrita una certa qualità, in passato molto valorizzata – penso ad esempio agli anni Sessanta. In questo senso, in che termini il suo lavoro partecipa di una nuova tradizione?
Io ho avuto la fortuna di lavorare in due film che hanno potentemente rilanciato il cinema italiano nella scena internazionale. Rispetto a questo io posso dire che Teatri Uniti, soprattutto sotto la spinta di Mario Martone, con il primo film Morte di un matematico napoletano, inventa una forma di cinema indipendente tanto quanto il teatro. Questo significa decidere di produrlo, distribuirlo, scegliere i testi, la storia, scegliere i compagni di viaggio, in una forma completamente indipendente e fuori dai circuiti commerciali che impongono un altro tipo di scelte. Il frutto di questo lavoro lo si raccoglie anche nella confusione – bella, felice – che poi c’è tra il pubblico teatrale e il pubblico cinematografico. Perché chi ci scopre in un mondo e poi incuriosito ci viene a seguire nell’altro vede che, per esempio, noi non siamo di quelli che intendono il teatro come un’anticamera per il successo cinematografico, ma invece – come accade in altri paesi, ma come è accaduto anche nel nostro in periodi gloriosi del nostro cinema – praticano le due discipline con la stessa passione e dedicandogli lo stesso tempo, per quanto possibile.
Lei ha lavorato come attore e poi come regista teatrale. Mi domando se ha considerato l’ipotesi di cimentarsi in una regia cinematografica.
No, non credo che accadrà. La scrittura cinematografica è un processo molto differente, per certi aspetti lo considero simile alla scrittura di un romanzo: la si porta dentro per molto tempo, conosce un momento pubblico, esterno alla mente dell’autore e alle sue ossessioni – il momento delle riprese – e poi ritorna a essere un momento molto solitario – nel lavoro di montaggio – come accade un po’ anche in letteratura. Invece io mi considero un interprete, non un creatore, quindi ho bisogno di lavorare su testi che pre-esistono, di cui mi innamoro e di cui posso dare una mia lettura. E poi il mio lavoro è un lavoro che non può prescindere dall’atto, dall’agire. Io mi testimonio criticamente nei confronti di un atto creativo nel momento stesso in cui lo compio. Non sono capace di compierlo senza che sia visto, che sia condiviso.
In che misura questo aspetto si concilia con l’interpretazione dei personaggi? I personaggi teatrali che incontra, di cui si innamora, la accompagnano anche in un percorso di anni – penso alla Trilogia della Villeggiatura, ad esempio, o a Sabato, domenica e lunedì – e nel corso degli anni il rapporto con il personaggio cambia, immagino. Il personaggio cinematografico, invece, viene fissato, non accompagna una durata della sua esperienza come attore.
Il personaggio teatrale cambia continuamente in relazione alle circostanze, alla tua vita; questa è la scimmia sulla schiena del mestiere dell’attore. Il personaggio cinematografico resta lì, quello che è fatto è fatto. Rivedendo i film ciò che si muove è una fotografia, il rapporto con il personaggio avviene prima. Nel corso di quattro anni della vita di un attore di teatro possono succedere tantissime cose e queste cose compromettono – nel bene e nel male – il suo rapporto col personaggio che sta recitando nel corso di quegli anni. Recitare in teatro è un compromesso che uno fa con la vita, c’è poco da fare. Perché decidi di mettere la tua vita a disposizione di quello che stai facendo tutte le sere, rendendola pubblica. Non è la stessa cosa dell’artigiano, che lavora in solitudine, risponde a certe regole; noi abbiamo degli orari da osservare, a quell’ora tutte le sere davanti a un certo numero di persone mettiamo in campo il risultato di un processo di lavoro che comincia quando decidi di fare lo spettacolo e finisce quando lo spettacolo sarà finito. Questo si carica delle energie di ciò che ti accade in quattro anni della tua vita, di quello che sta accadendo nel paese in quel momento, delle abitudini legate a un teatro piuttosto che a un altro, a un pubblico piuttosto che a un altro, a una nazione piuttosto che a un’altra – e questo alimenta e nutre il rapporto dell’attore e del personaggio. Quello che tu metti in scena è un segmento importante della tua giornata ed è pubblico, è condiviso. Questo è importante: non è solitario, è condiviso, accade in una situazione pubblica.
E’ un compromesso con la vita, perché uno si dà, e darsi è donare qualcosa. Donare significa togliersi qualcosa, darla. Per capire qualche cosa di questo mestiere: quello che sta accadendo a me, ad esempio, è che io recito duecento sere all’anno. Altro è l’attore che recita trenta giorni all’anno. E’ anche quello un attore, che però ha un rapporto eclettico col mestiere. Farlo tutti i giorni senza la routine significa che tu ti devi mettere d’accordo con la vita. Questi sono i segreti di un attore.
M’interessa approfondire questa dimensione ‘pubblica’ del suo lavoro, su cui è tornato diverse volte. Nel numero di Art’O #29 ci siamo interrogati sulla ‘politica’ e mi piacerebbe sollecitarla su questo punto, proprio in relazione alla dimensione pubblica del suo lavoro: ha senso e in che termini lo ha considerare un lavoro artistico un lavoro politico?
Io ho una profonda coscienza del fatto che qualsiasi lavoro pubblico è un lavoro politico, perché mette in circolazione delle idee, degli atteggiamenti, degli esempi. Il teatro è un’assemblea civile, non è un luogo dove sfogare il nostro narcisismo. Ogni gesto pubblico è un gesto politico perché mette in circolazione tutto quello che ci siamo detti e quindi, prima che questo gesto sia compiuto in pubblico, occorre avere un senso di responsabilità e una consapevolezza di quello che si fa. E questo è politico, secondo me. Questo è la base di qualsiasi rapporto politico corretto, di qualsiasi scambio e comunicazione di idee che abbia un senso di civiltà e di responsabilità. Io non potrei immaginare stasera di andare sul palcoscenico e improvvisarmi, presentare una pagliacciata. Approfitterei di persone che si sono riunite per pensare, per emozionarsi, per ridere, anche, ma in maniera responsabile. Molto teatro che si fa non con questo atteggiamento è un teatro narcisistico, che serve a sfogare gli istinti di alcuni e di cui noi siamo vittime come spettatori. E’ un teatro impiegatizio. Chi sta sulla scena fa un lavoro con lo stesso atteggiamento routiniero, noioso, senza nessun piacere, senza nessuna soddisfazione. Io credo che il teatro è politico in quanto pubblico, in quanto si mette all’interno di una serie di relazioni che sono relazioni civili e condivise; e che esercita la sua funzione nella consapevolezza della responsabilità di far ciò, quale che sia la proposta culturale che si fa.
Articoli correlati