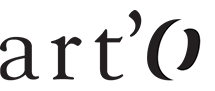La sensibilità di Santarcangelo per il teatro. Uno sguardo sul festival
In realtà volevo partire dai contenuti sensibili. Poi è successo quel che si sa, l’affaire Massini, chiamiamolo così, che dopo due giorni già non se ne parlava più, finito l’effetto della “polemica” che serve a far audience. Ma poi, altri declassamenti veri e presunti, proteste indignate, ricorsi già in atto o minacciati. E anche Santarcangelo ha avuto la sua parte, giacché il festival ha visto dimezzato il punteggio dalla commissione ministeriale rimasta orfana dei rappresentanti dell’opposizione parlamentare. E chi da sempre frequenta Santarcangelo non può certo restare indifferente alle parole appassionate pronunciate dall’assessore regionale in difesa della libertà dell’arte dai condizionamenti della politica. Su cui però anche il suo partito ha forse qualcosa da farsi perdonare. Possiamo sperarci per il futuro?
E i contenuti sensibili? È successo un poco alla volta, non ci si è fatto caso. Adesso è diventato impossibile ignorare il fenomeno. Sui programmi dei festival, sui cartelloni delle stagioni teatrali, la prima voce che si incontra sono i contenuti sensibili, l’elenco cioè di quanto nella performance potrebbe turbare gli spettatori. Sfoglio il programma di Santarcangelo, Not yet si intitola quest’anno il festival tutto coniugato al femminile, ma alla Biennale veneziana era lo stesso. Luci stroboscopiche o intermittenti, musiche ad alto volume, scene di nudo, presenza di odori forti, riferimenti alla cultura dello stupro o al profilamento razziale, immagini di violenza, vicinanza con i performer… Arrivato a utilizzo di curcuma e peperoncino in polvere, mi sono fermato. Tutto giustificato per carità, però.

La nudità per esempio è imputata a Boujloud di Kenza Berrada, giovane artista franco-marocchina di cui poco dicono le note biografiche. Nella penombra della scena la vediamo infatti avanzare carponi con le tette al vento (copyright Francesco Guccini) lungo il percorso tracciato da un cerchio di pelli di pecora distese a terra. Quale sensibilità possa essere turbata da questa immagine, non è facile capirlo. Berrada la usa forse per dare corpo (letteralmente) a un contenuto che altrimenti rischierebbe facilmente di scivolare nell’inchiesta sociologica. Il tema è quello dell’abuso sessuale, di cosa voglia dire consenso fra le donne della sua generazione nel paese che ha lasciato a tredici anni. Ho 36 anni e sono nell’appartamento vuoto di mia nonna, comincia. Ho 34 anni e sto ballando intorno a un fuoco. Ho 7 anni e mio cugino 17. Lui aveva 37 anni, io 17. Le storie si intrecciano nello spazio e nel tempo, fino a confondersi. Sempre con quel rumore di fondo, le voci di coloro che raccomandano di stare zitta, di non parlarne. Anche voci femminili, certo. Sul fondo si succedono immagini sfocate di luoghi che forse le sono familiari. Bisogna prendere a colpi d’ascia la correttezza, ripete più volte. Perché il culto della gentilezza ci disconnette dal nostro corpo. E forse per questo indossa la maschera violenta del Boujloud, la figura che appare in riti ancestrali che si celebrano nelle regioni montuose del Rif, nel nord del Marocco. Giovani uomini si coprono di pelli di pecora e inseguono le donne colpendole con dei rami. È la tradizione, dona fertilità, però.

C’è una data anche all’inizio di Rapeflower di Hana Umeda, stessa generazione più o meno di Kenza Berrada, polacca con studi a Berlino. La troviamo già distesa su un fianco, sul fondo della scena, annegata fra gli alberi di un bosco dall’uniforme colore giallo. Nuda, come resterà fino alla fine. Diciotto anni fa sono stata violentata, sono le prime parole che ascoltiamo. E un po’ alla volta si capisce che rispondono a una reale esperienza personale. E quel corpo nudo, esposto in una luce che non lascia ombre, nella sua oggettività priva di allusioni erotiche, quel corpo è il contenuto del suo racconto, il suo testo. E ancora una volta torna la domanda, quale sensibilità può essere turbata da questa immagine. Lei si racconta attraverso i gesti della danza Jutamai e le parole della sua maestra, che risuonano come lontane nel tempo. Ho cominciato a praticare questa danza diciotto anni fa. Inspira, espira. Apri il ventaglio. Stringi le cosce e le ginocchia. Abbassa i fianchi. Lei ubbidisce. Di nuovo. Non chiudere gli occhi. Concentrati sul ritmo del tuo respiro. Di nuovo. Si sposta nelle postazioni disegnate a terra. Manovra il ventaglio che è l’indispensabile complemento dell’antica danza giapponese riservata alle donne. Mentre vieni violentata è meglio chiudere gli occhi o tenerli aperti? Non a caso il racconto cerca un contrappunto visivo nei dipinti di Artemisia Gentileschi proiettati per frammenti anche sul suo corpo. Donne che si uccidono per la vergogna di essere state violentate. Per concludere invece che sì, sei stata stuprata. Non è stata colpa tua.
 Archivio spettrale di sensualità inespressa, definisce il programma il lavoro di Ewa Dziarnowska, anche lei polacca ma residente a Berlino da una decina d’anni. Chissà cosa vuol dire. Tutto quello che sappiamo di This resting, patience, quando entriamo nel capannone industriale in disuso dove è allestito lo spettacolo, è che dura tre ore ma si può uscire e rientrare a piacere, le porte sono aperte, non ci sono posti assegnati. All’interno ci sono delle seggiole disposte tutt’intorno, al centro lei sta ballando sulle note di una vecchia canzone di Burt Bacharach. What the world needs now is love. Quando finisce non si arresta, anche perché la musica ricomincia subito. È alta, anche a piedi scalzi. Corpo statuario, si dice. Indossa un lungo abito azzurro di un tessuto leggero, molto trasparente e scollato sulla schiena, che non lascia molto da fare all’immaginazione.
Archivio spettrale di sensualità inespressa, definisce il programma il lavoro di Ewa Dziarnowska, anche lei polacca ma residente a Berlino da una decina d’anni. Chissà cosa vuol dire. Tutto quello che sappiamo di This resting, patience, quando entriamo nel capannone industriale in disuso dove è allestito lo spettacolo, è che dura tre ore ma si può uscire e rientrare a piacere, le porte sono aperte, non ci sono posti assegnati. All’interno ci sono delle seggiole disposte tutt’intorno, al centro lei sta ballando sulle note di una vecchia canzone di Burt Bacharach. What the world needs now is love. Quando finisce non si arresta, anche perché la musica ricomincia subito. È alta, anche a piedi scalzi. Corpo statuario, si dice. Indossa un lungo abito azzurro di un tessuto leggero, molto trasparente e scollato sulla schiena, che non lascia molto da fare all’immaginazione.
A volerla prendere come una trilogia del corpo, questa vista a Santarcangelo, potremmo dire che si chiude sul terreno della sensualità, della seduzione come forza motrice di una educazione teatrale che è anche sentimentale. Lei continua a danzare, ferma nello stesso punto, variando l’energia dei gesti mentre la canzone si ripete in loop. Sono soprattutto le braccia a guidare i movimenti, gli slanci, le rotazioni. Un po’ distante è apparsa una seconda danzatrice, jeans strappati e una camiciola che si apre da tutte le parti. Dopo tre qu arti d’ora la canzone si interrompe. Lei va a cambiarsi d’abito da un lato, in mezzo agli spettatori. La musica diventa un cupo rimbombo di suoni percussivi, esplode in un rock no-wave, scivola verso ritmi disco e elettronica da rave party. Le due interpreti ora si muovono soprattutto al suolo, rotolando inarcandosi sollevandosi. Dopo un’ora sai già che non uscirai più. È teatro, come ci si poteva aspettare e prevedere. Fatto con la stoffa del tempo. Sei incatenato lì. Torna in mente la prima volta che vedemmo uno spettacolo di Jan Fabre, a Polverigi. Eravamo ragazzi. La serata si annunciava molto lunga. Alle prime luci del giorno eravamo ancora lì, su quella scomoda gradinata. Paragone ingombrante, ne sono consapevole. Ma è per dire che talvolta il teatro ha in sé una forza che va oltre il performer. Che intanto passa in mezzo agli spettatori, la performer, sfiorando leggermente qualcuno. Ricomincia la canzone di Burt Bacharach. What the world needs now. Si esce leggeri nella notte di Santarcangelo.
© Gianni Manzella