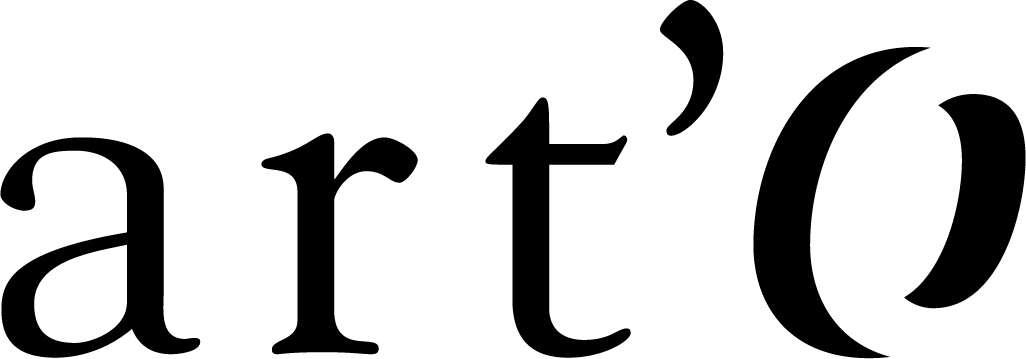Davanti al dolore degli altri. La Bestemmia del Teatro Valdoca che apre un futuro diverso
Questo presente bestemmia contro la parola, contro l’umano, contro tutto ciò che vorrebbe nascere e portare il proprio frutto. Per una volta non è sbagliato partire da qui, dalle parole che aprono il breve scritto di presentazione dello spettacolo che si intitola Bestemmia, appunto. Ed è come se gli artefici del Teatro Valdoca ci fornissero il vocabolario per penetrare in un significato più profondo della parola. Anche la bestemmia può essere una forma di preghiera, insegnavano i mistici. Ma non qui, non in questo tempo. Ci è toccato di essere qui – dicono le “parole alla città” pronunciate da Mariangela Gualtieri dall’alto di un balcone dell’ottocentesco Teatro Bonci, a Cesena. Da celebrante di un rito antico, a cui siamo chiamati a partecipare, tutti noi raccolti nella piazza lì sotto a guardare in su, sarà la suggestione del colonnato ionico modellato sulla facciata del teatro. Ma mi piace pensarla piuttosto come una Sibilla costretta a tenere da parte l’enigma che avvolge la parola poetica, ed è un po’ la chiave di tutto il lavoro creativo di Valdoca, per dire di un’urgenza nuova. No paroline, non dire le cosucce – dirà qualcuno degli interpreti.
Ci eravamo lasciati quattro anni fa davanti alla sala svuotata del teatro dedicato al tenore Alessandro Bonci, nel tempo che seguiva il silenzio iroso della pandemia. Ora siamo di nuovo qui, a spiare dai palchi una scena che come allora si è dilatata a invadere tutta la platea svuotata dalle poltroncine. In un tempo mascherato reso ancora più opprimente dagli incessanti rumori di guerre aizzate dai volenterosi “masters of war”. Per entrarvi abbiamo dovuto circumnavigare la porta della sala, ostruita da un carretto pieno di povere cose contadine. Borse gonfie di panni, fasci di canne. Gli oggetti raccolti per costruire una scena che non ha avuto luogo. Forse per questo mi viene in mente il carretto che porta alla villa del mago Cotrone la Contessa dei Giganti della montagna.

Per riannodare un filo che non si è mai spezzato, un mese fa o poco più ero andato a trovare Mariangela e Cesare all’Arboreto di Mondaino, dove la compagnia aveva trovato ospitalità nella preparazione del lavoro, prodotto insieme a Emilia Romagna Teatro. Con la gioia del ritrovare il lessico familiare di Mariangela Gualtieri. Così intimo e tuttavia mai intimistico, ché l’intimismo è la nefasta metastasi dell’intimità. Sulla pedana preparata sotto la cupola sferica del “teatro dimora”, in mezzo al bosco di questo angolo di Romagna, stavano dispiegati gli arnesi spesso evocati sulla scena di Cesare Ronconi. Come un segno di continuità all’interno di una visione artistica tanto radicale nella volontà di non cedere a compromessi. A Cesena, non è più così. Sul palco è rimasto solo un grosso tubo sospeso a due funi, come un’altalena, che a tratti infatti viene fatto oscillare.
Le poltroncine sono state accatastate in maniera ordinata in grandi blocchi squadrati coperti da bianchi lenzuoli funebri e intorno a essi il reticolo di strade di una città scomparsa. Inevitabile pensare al Grande Cretto di Burri disteso a coprire le rovine della vecchia Gibellina distrutta dal terremoto. O all’ingrandimento, proprio nel senso di un blow-up fotografico, di una minima porzione di cimitero ebraico, ultimo desertico paesaggio di morte dove le basse pietre tombali stanno allineate l’una accanto alle altre. Sempre lì si è ricondotti. Ma qui c’è un altro dolore con cui fare i conti. Un esplicito porsi di fronte al dolore degli altri, come scriveva Susan Sontag. Gli altri di cui non sentiamo il lamento. Pensare la fame di altri, qualcuno che non è tuo padre o madre e nemmeno vicino di casa.
Negli spazi che si intersecano vagano poche sperdute figure, forse i sopravvissuti di un’umanità che ancora trema vedendo l’umano armato e spietato. C’è la ragazza dei segni, Eugenia Giancaspro, che dall’alto di uno sgabello parla coi gesti a chi non può sentire e chi può sentire non comprende quei gesti. C’è il ragazzo pensoso, Nico Guerzoni, forse un angelo caduto che tiene contro il petto nudo un paio di ali spiegate. E l’uomo dolce e forte, Giuseppe Semeraro, che vaga sul palco con o senza un monociclo, a volte trascina una slitta. E poi la ragazza che canta, voce sublime quella di Sara Bertolucci, sia che con le sue improvvisazioni sia chiamata a far da contrappunto alla musica suonata dal vivo da Lemmo, sia che ai piedi del palco duetti con la ragazza dei segni, minuscolo simulacro di un coro.
Siamo nel tempo intermedio dell’attesa. Quello vecchio è finito e il nuovo non è ancora arrivato. Così dicono. Dunque un tempo purgatoriale, il paradiso è un appena appena, dura poco poi si richiude, dicono i versi di Mariangela Gualtieri – e l’inferno, l’abbiamo imparato, l’inferno esiste solo per chi ne ha paura. Il ragazzo pensoso guarda lo sfacelo delle case buttate giù e si chiede se c’è una distanza vera fra sé e chi ha devastato, se le macerie che vede sono già dentro di sé. L’uomo dolce e forte interroga il mondo con un megafono per farsi sentire: che cos’è l’acqua? Che cos’è il vento? E la città gli alberi la notte. Sullo sfondo resta sospesa la domanda che rimbalza: che ne facciamo del sangue versato e le macerie dove le mettiamo? Fare male a qualcuno che l’uccisore non conosce, spaccare le vite di altri, esaurire il loro respiro.

Non sono sole, quelle presenze spaesate. Su fondo della sala si alza una sorta di podio o di altare; in cima una lettiga di legno è lo spazio riservato alla donna che guarda, Mariangela Gualtieri, che in questo modo assume anche il ruolo dello spettatore. Accanto a lei Silvia Calderoni, con un cappellino di carta che si prolunga a formare una maschera indecifrabile, è un folletto inquieto, uno spirito dell’aria che la stringe a sé e la trascina nella corsa e punta davanti a sé con mani tremanti una pistola che non sparerà. Lasciamo in pace le sere dentro le case, dice la donna che guarda con parole che emozionano, che allargano il vivente a tutto ciò che intorno a noi respira e chiede la nostra cura. Sono parole di speranza che aprono a un futuro diverso. Uscire subito da qui. Essere vivi. Accettare la ferita. Trasformare il dolore in bellezza.
© Gianni Manzella