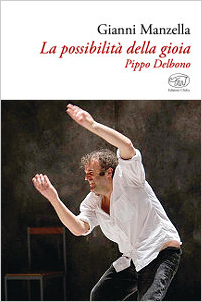-
Vita oscura smarrita. L’Inferno di Marco Martinelli e Ermanna Montanari per il Ravenna festival
Vita. Oscura. Smarrita. Sono le tre parole propiziatorie che presiedono all’Inferno realizzato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari a Ravenna. Parole totem, potremmo quasi definirle. Alle quali si è chiamati a cercare un’intima corrispondenza in una sorta di cerimonia di iniziazione. Sono quelle che chiudono i versi della prima terzina del poema dantesco, naturalmente, ma ad ascoltarle così, isolate nella loro nudità e dunque sottratte in qualche modo a un contesto, a cominciare dai ricordi scolastici, sembrano evocare una oscurità e uno smarrimento collettivi a cui bisogna rispondere con la vita.
Vestiti di bianco, i due artefici hanno accolto gli spettatori davanti al tempietto dove sta la tomba di Dante. È l’ora del tramonto, c’è ancora luce. Annunciati dal suono di una grande conchiglia, hanno preso a dire i versi della Commedia dal grande libro che tengono di fronte. E il coro dei cittadini lì convocati gli fa eco, dando impulso alle parole con un gesto della mano che sembra spingerle in avanti. Del resto da una “chiamata pubblica” prende le mosse l’evento promosso lungo più di un mese dal Ravenna festival. Quasi un migliaio di cittadini hanno sorprendentemente risposto all’appello lanciato, partecipando a turno alla preparazione dello spettacolo e poi alla sua rappresentazione.
C’è nel capolavoro fondativo della nostra identità nazionale una teatralità spontanea che ha attratto e messo alla prova nel tempo artisti dalla sensibilità assai diversa. Con una comprensibile prevalenza, quanto agli esiti, proprio per le sulfuree immagini dell’Inferno. Dall’ormai lontana trilogia di Federico Tiezzi, che rileggeva le tre cantiche all’insegna di un possente teatro di poesia chiamando in causa tre poeti contemporanei, alla leggerezza giovanile con cui Eimuntas Nekrosius la trasponeva fra sogno e gioco, ben sapendo che da quei sogni e giochi che un poco vorrebbero farci paura non c’è da temere nulla. Martinelli e Montanari hanno scelto invece come punto di partenza la strada della rappresentazione popolare, in linea con l’aspetto sacro del poema ma guardando anche alle esperienze partecipative di teatro politico che si allungano per tutto il Novecento, dagli anni della rivoluzione sovietica alle sue diramazioni di gruppo e di strada ancora vive negli anni sessanta e settanta.
Ecco allora che seguendo i due artisti ci si avvia lungo le strade della città, preceduti dal suono di una tromba. Ci si arresta davanti a Sant’Apollinare Nuovo, dove li affianca per momento una giovanissima Beatrice. Poi via di nuovo verso l’antica chiesa romanica di Santa Chiara che oggi è il teatro Rasi, da un quarto di secolo sede delle Albe. Per me si va, sta scritto al sommo della porta, e bisogna sottoporsi a un altro rito di passaggio per entrare nella preannunciata città dolente. Ma oltrepassata questa soglia, tutto d’improvviso cambia. Il colore della rappresentazione, per così dire. Da partecipi di un rito collettivo gli spettatori si trovano precipitati in una bolgia davvero infernale di uomini armati. Accomunati alla perduta gente. Senza più guida alcuna, senza difesa. Più che una massa di diavoli è una soldataglia urlante che spinge e preme mentre il loro capo detta ai vinti le condizioni dei conquistatori con le parole della Venezia salva di Simone Weil. L’esaltazione della violenza come tecnica di controllo.

E quando con un po’ di sollievo si riesce a passare oltre, ecco che il teatro appare letteralmente ribaltato (l’allestimento scenico è firmato da Edoardo Sanchi). La sala è stata svuotata. Tutt’intorno vi corre una pedana da cui si alzano scale a pioli. Dappertutto si moltiplicano i gruppi urlanti, non solo soldati ma anche furenti Erinni. Lì nel mezzo coppie di ragazzi sussurrano le parole di Paolo e Francesca o si assiste al violento accapigliarsi a terra delle schiere opposte di avari e scialacquatori. Tre musicisti se ne stanno sotto il sipario rosso che chiude l’arco scenico a distillare i suoni dolcemente percussivi di Luigi Ceccarelli.
Si sale in galleria dove le voci di Farinata e del vecchio Cavalcanti in divisa militare si levano di fronte a immagini di esplosioni vulcaniche e fiumi lavici. Dall’alto si guarda giù alla selva dei suicidi dove sta Pier della Vigna, come in un estremo teatro anatomico, mentre stinte immagini di Pasolini si riconnettono in maniera trasparente al magistero intellettuale di Brunetto Latini. Poi ciascuno per suo conto può affacciarsi nelle Malebolge delle stanzette degli uffici dove si reiterano altre stazioni di un infermo molto contemporaneo. Un ruffiano mette in vendita una ragazzina; un alto prelato in odor di simonia invita a farsi un selfie; si ascolta la voce di Ezra Pound che cantilena i suoi versi contro l’usura. E si scende di nuovo pericolosamente in un manicomiale spazio bianco dalle pareti imbottite, dove i rinchiusi in camicia di forza vagano indifferenti alla violenza verbale di Vanni Fucci. Ogni tanto Martinelli cava di tasca un bigliettino e legge una frase di Boccaccio o del figlio di Dante, Jacopo, il primo commentatore della Commedia.
Sono gli attori delle Albe a dare corpo alle figure principali dell’Inferno, trasportati anch’essi nel flusso vorticoso dello spettacolo. Fino al folle volo di Ulisse che dall’alto di una vertiginosa pedana mobile rammemora l’ultima sfida al bisogno di conoscenza che l’ha spinto oltre i confini del mondo conosciuto. Sono Roberto Magnani, Luigi Dadina, Alessandro Argnani, Alessandro Renda, Laura Redaelli che guida il coro delle Erinni – mentre il moltiplicarsi discreto delle apparizioni di Montanari svolge anche una funzione di tessitura delle rifrazioni della drammaturgia. Ma è il sentimento collettivo di questa impresa che accompagna mentre si sprofonda nello spazio ritrovato al di sotto del piano della scena, dov’era l’abside della chiesa. Prima di uscire a riveder le stelle, salutati uno per uno da Ermanna e Marco. Fuori, un’altra scala appoggiata a un antico albero sale verso un’altezza preclusa alla vista. Verso quelle altre due cantiche del poema che prenderanno forma nei prossimi anni.
Articoli correlati