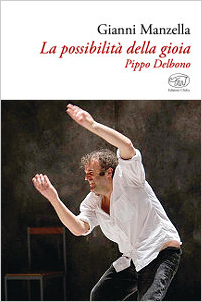-
Una Carmen partenopea per Martone
“Se io t’amo, st’attiento a te!”, dice Carmen: “L’ammore è n’auciello furesto”. Non è difficile riconoscere la celebre habanera con cui si presenta la bella gitana nell’opéra-comique di Georges Bizet. Ma qui stiamo da tutt’altra parte, lontani dai remparts di Siviglia. Di una Carmen ferocemente partenopea si tratta, pronta a rivendicare anche i luoghi comuni di questa sua appartenenza. E dovremmo più propriamente chiamarla Carmèn, insistendo sull’accento tronco; anzi Lacarmèn come suona in origine il titolo dato da Enzo Moscato alla rivisitazione del dramma, da cui Mario Martone ha tratto lo spettacolo fosco e trascinante che ha debuttato al Teatro Carignano (lo producono gli Stabili di Torino e Roma).
 Una Carmen di Porta Medina, per così dire, più prossima forse a Francesco Mastriani che a Mérimée, anche se dal suo più lontano prototipo letterario viene la scelta di raccontare la vicenda come già avvenuta, facendola evocare dai protagonisti per ondate di memoria. Dando anzi voce a entrambi, perché non c’è mai solo un lato da cui guardare le cose. Ecco infatti lei che accecata da un paio di occhiali scuri ma in abito elegante percorre il perimetro del palcoscenico, rivendicando contro il sentire comune la sua duplicità, pessimo soggetto ma anche donna riflessiva – tanto da identificarsi quasi con la città. Mentre lui, che ha nome Cosé, siede grigio e accasciato nel suo carcere, imprigionato dal ricordo prima ancora che dalla cella di Procida, a Terra Murata.
Una Carmen di Porta Medina, per così dire, più prossima forse a Francesco Mastriani che a Mérimée, anche se dal suo più lontano prototipo letterario viene la scelta di raccontare la vicenda come già avvenuta, facendola evocare dai protagonisti per ondate di memoria. Dando anzi voce a entrambi, perché non c’è mai solo un lato da cui guardare le cose. Ecco infatti lei che accecata da un paio di occhiali scuri ma in abito elegante percorre il perimetro del palcoscenico, rivendicando contro il sentire comune la sua duplicità, pessimo soggetto ma anche donna riflessiva – tanto da identificarsi quasi con la città. Mentre lui, che ha nome Cosé, siede grigio e accasciato nel suo carcere, imprigionato dal ricordo prima ancora che dalla cella di Procida, a Terra Murata.Ma ecco che la scena si anima. Gettati via gli occhiali scuri, ritrovato il conforto di un fiore rosso, la Carmen di Iaia Forte tira fuori tutta la carica seduttiva della cattiva ragazza. Balla e canta. Scuote i fianchi. Fa scendere le mani lungo il corpo. Alle minacce o alle profferte risponde con un Tra-la-la. E però ha una sua legge, la legge di quelle come lei, e non dimentica di pagare a suo modo il debito con quel surdatiello innamorato che l’ha lasciata fuggire quand’era già in manette, il Cosé di Roberto De Francesco che non avrebbe neppure bisogno dell’accento veneto per rivelarsi forestiero, giacché a tradirlo è prima di tutto l’impaccio fisico. Salvo poi urlargli dietro il suo “vattènne, vattènne” quando lui tentenna all’idea di seguirla.
Le due spesse mobili pareti che stringono la scena in una morsa si aprono come un libro illustrato per l’infanzia rivelando l’interno spoglio di una stazione di polizia dove il tenente Zuniga siede stravaccato con i piedi sulla scrivania o la “mala taverna” di Lilà Bastià (tutti i nomi hanno subito qualche adattamento all’uso locale) che è un po’ il ritrovo di tutti, non solo contrabbandieri e ragazze allegre. C’è effettivamente qualcosa della semplicità del teatro all’antica nella scena disegnata da Sergio Tremonti, un’esibizione di cartapesta che si tiene ben lontana da una ricostruzione naturalistica.
Il recupero di una teatralità popolare è la chiave scelta da Martone per questa sua impresa, nel segno di un teatro musicale che guarda a Raffaele Viviani (non sono poi lontani I dieci comandamenti realizzati anni fa dal regista) ma che non disdegna di scendere nei bassifondi della sceneggiata, apertamente citata del resto nel personaggio di ’O Torero che è appunto un cantantuccio da sceneggiata, un mezzo buffone con la fissa di atteggiarsi a baritono. (Eppure lei se ne incapriccia). E il merito della riuscita va anche all’Orchestra di Piazza Vittorio diretta da Mario Tronco che invade lo spettacolo con le sonorità multietniche in cui disciolgono le arie più celebri di Bizet e si proietta anche sul palcoscenico con i suoi interpreti in costume, sorta di coro di questa tragedia apocrifa. E in un crescendo rutilante porta diritto a una sorta di festa di Piedigrotta, che raccoglie attorno a un carro addobbato di luminarie una Napoli meticcia. Che forse non può essere altra che se stessa, la città, ma non può negarsi al cambiamento.
Finisce come deve, con un coltello. Ma questa volta lui non uccide, sceglie di colpire quegli occhi avvelenatori. “Si je t’aime, prends garde à toi”, diceva Carmen con le parole di Meilhac e Halévy, e una densità semantica irriducibile a qualsiasi traduzione. Guardare, guardarsi, stare in guardia. Ma la scombinata zingarella di un tempo non c’è più. Così come la visione del sentimento come forza radicale di sovvertimento, come lucido gioco di destini. Fra la puttana e la filosofa, come si era definita, Carmèn ha scelto la via più aggiornata dell’imprenditoria, da gran madama dei bordelli, eleganti naturalmente. Le storie d’amore van bene per gli stupidi.
© gianni manzella
Articoli correlati