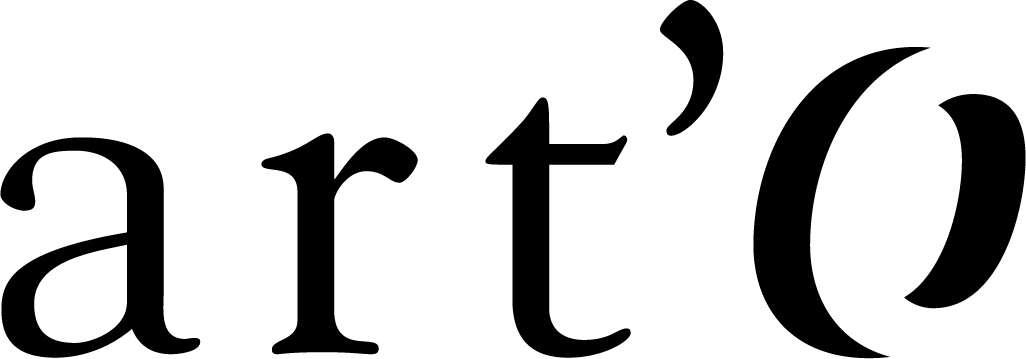Tragedia della perdita. Shirin Neshat mette in scena Orfeo ed Euridice al Regio di Parma
La luce che cade dall’alto all’interno della stanza, da una finestra alta e stretta posta di necessità a sinistra, richiama un poco certi dipinti di Vermeer. La donna è seduta sulla sponda del letto, in faccia alla finestra; l’altro, l’uomo, le volge le spalle, sull’alto lato del letto, ma la sua presenza sembra solo complementare nel quadro, come spesso avviene con Vermeer. Non si parlano, non si guardano. Qualcosa di luttuoso aleggia intorno a loro. Del pittore di Delft mancano i tenui colori, qui tutto è immerso in un nitido grigiore. La donna si alza e avvicina alla finestra. Fuori le pare di scorgere l’immagine confusa di un bambino che cerca di uscire dalla nebbia. Allora sale sul davanzale e si lascia cadere nel vuoto. Intanto è partita l’ouverture. Perché siamo all’interno di un teatro, nel trionfante rosso e oro del Regio di Parma, dove va in scena Orfeo ed Euridice, azione teatrale per musica composta intorno alla figura della mitologia greca da Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri de’ Calzabigi.
Tutto è immaginato visivamente in bianco e nero, nella regia di Shirin Neshat che ha creato una cornice contemporanea in cui inserire l’opera di Gluck. Come se questa fosse visione disperante a confronto con l’irrimediabile realtà della perdita. Non si torna indietro, il perduto è perduto. Quando si solleva il grande schermo che chiudeva il boccascena, sulla scena ritroviamo lo scabro interno domestico dov’è ambientato il film iniziale. Il corpo della novella Euridice è disteso a terra come l’avevamo visto precipitare in un moto rallentato, nella stanza spoglia dove uno specchio da terra replica quello presente nella camera da letto. In cui il soggetto si guarda, e guardandosi trova il suo doppio. La multiforme artista iraniana di nascita ma trapiantata da tempo a New York ha lavorato molto, agli inizi soprattutto, fra le installazioni video e le grandi fotografie che rimandano all’evidenza dei corpi, celebri quelle di mani e visi di donne interamente ricoperti dalla calligrafia della scrittura araba. Qui tutto converge.
Diversi piani si sovrappongono e slittano l’uno sull’altro senza collidere in questo concentratissimo Orfeo ed Euridice. Alla base c’è uno dei miti dell’antichità che maggiormente si rifrangono nella memoria collettiva, torna in mente l’Orfeo inconsolabile dei Dialoghi con Leucò di Pavese – non si ama chi è morto. E c’è l’impronta di una civiltà musicale, quella settecentesca, che forse è più lontana da noi del mito greco. Ma quell’iterativo rondò del terzo atto – Che farò senza Euridice, dove andrò senza il mio ben – chi non l’ha ascoltato almeno una volta. C’è il tema dell’identità femminile che percorre gran parte del lavoro di Shirin Neshat; le immagini filmate che danno forza visiva al racconto, e la zona oscura della mente, la contiguità fra il sogno doloroso e l’inconscio, verso cui l’artista iraniana ha spostato la trama nascosta dell’opera, senza nessuna tentazione di attualizzarne il contenuto. E il senso di intimità sospesa dell’interno domestico vira verso questo buco nero.

Ecco il protagonista di fronte alla gigantesca porta che chiude l’ingresso agli inferi, guidato da un inquietante Amore in soprabito bianco e con ali più grandi di lui, come l’angelo de Il cielo sopra Berlino. E quando la porta si apre e lo sguardo penetra in quell’onirico aldilà, ecco una sorta di teatro anatomico affollato da un coro vociante che si affaccia dai balconi dell’emiciclo, pronto a trasformarlo nell’aula di un tribunale. Fra sbuffi di fumo, un corpo inerte viene spinto al centro su un letto operatorio, attorno a cui danza un sabba di infermiere o segretarie tutte uguali in quel loro tailleur grigio dei passati anni Cinquanta. E quando quelle erinni si trasformano in benevole eumenidi e lasciano partire la donna, eccolo vagare alla ricerca di lei in mezzo a una massa di creature con il nome appeso al collo. Poi si sa come vanno le cose, lei lo supplica di guardarla, lui per un po’ resiste ma poi si volta indietro e lei muore di nuovo. Tocca al diavolaccio alato, di fronte a tanto struggente amore, riportare in vita Euridice. Ricoperta di fiori rosa, di cui lei subito si spoglia.
Un’ovazione alla fine per il maestro Fabio Biondi alla testa della Filarmonica Arturo Toscanini e per gli interpreti che sono il contralto Carlo Vistoli e le soprano Francesca Pia Vitale e Theodora Raftis, ma ci sono tanti applausi anche per il coro dal ruolo cruciale nell’opera. Qualcuno uscendo si interroga su quel lieto fine di maniera pensato per il pubblico di un’altra epoca (o forse non solo per quello). Ma lo sguardo di Shirin Neshat è meno compiacente. Il sogno è finito. Siamo ritornati alla situazione di partenza, nella grigia camera da letto dove una coppia non si parla più. Il tempo si ricuce. La donna si avvicina lentamente alla finestra mentre si spegne la musica.
© Gianni Manzella