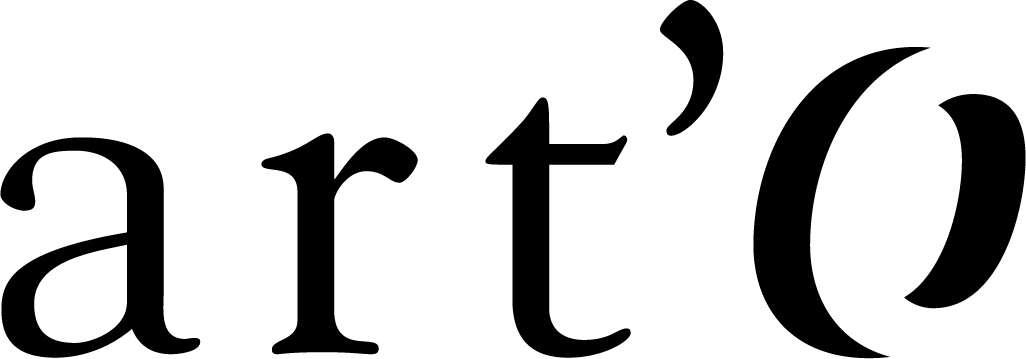La piccola frase di Eduardo. A proposito di Sabato, domenica e lunedì
Sostiene De Fusco che Sabato, domenica e lunedì è il testo più borghese del teatro di Eduardo. Quasi cechoviano, come altri avevano già notato, per l’analisi da entomologo della grande famiglia che si divide la scena. Una famiglia da teatro comico napoletano, dice a un certo punto uno di loro. E infatti distribuisce i ruoli, per così dire, ci sono la prima attrice e la caratterista comica, l’attor giovane e il generico primario, fino al mamo, colui che in commedia gioca il ruolo del giovane sciocco e melenso. E il regista napoletano, oggi direttore del Teatro di Roma, sembra aver preso sul serio questa battuta. Il capolavoro di Eduardo De Filippo diventa infatti sul palcoscenico dell’Argentina (dove è in scena fino al 6 gennaio) una commedia assai divertente, e non solo per merito della bravissima protagonista, Teresa Saponangelo, giacché tutta la numerosa compagnia l’asseconda con studiato mestiere.
Una commedia senza zone d’ombra. Col suo ipotetico lieto fine a sugellare la riconciliazione fra i due coniugi. Sostiene De Fusco che Sabato, domenica e lunedì commuove perché evidenzia la capacità di questa grande famiglia di comporre i conflitti, di saper curare le proprie ferite. Con un po’ di polemica nei confronti della figura del regista-demiurgo che tende a diventare il vero autore dello spettacolo. Eduardo, come Goldoni, si può interpretare ma non stravolgere. E su questo è impossibile non essere d’accordo. La questione è semmai quali siano i limiti di quell’interpretare, se vi sia cioè l’interpretazione canonica da osservare. Tanto più in un caso come questo, in cui manca la registrazione televisiva firmata dall’autore nel 1962, all’epoca cancellata dalla Rai per riutilizzare il nastro. Manca cioè quel testo secondo che altre volte consente una lettura parallela del teatro di Eduardo.
Si capisce che Luca De Fusco ce l’ha in maniera niente affatto velata con il meraviglioso spettacolo di Toni Servillo con Anna Bonaiuto, andato in scena più di vent’anni fa. Che andava in direzione ostinatamente contraria a una lettura a una sola dimensione, bonaria e sentimentale. Del resto era stato proprio Eduardo a notare come la commedia anticipasse il tema del divorzio. Al centro c’è infatti la disgregazione della famiglia basata sul matrimonio, e chissà se è vero che basta parlarsi, come vuole la lettura ottimistica del testo. La convinzione che lieto fine apparato per il pubblico, o almeno la sua parte più tradizionale, nasconda in realtà qualcosa di diverso, più contraddittorio, meno consolatorio.
I temi sono tutti già lì, nella prima scena di quel luminoso sabato napoletano in cui Rosa Priore sta trafficando in cucina con il pezzo di annecchia destinato alla preparazione del tradizionale ragù del rito domenicale, meticolosamente descritto nel testo. Era il tipo che ti dava soddisfazione, dice lei riferendosi al padre. Il marito no, Don Peppino è superiore a queste cose. Se fosse per mio marito cucinerei pasta scaldata pure la domenica di Pasqua, chiosa acidamente. Lui, Peppino Priore, arriva e si butta su una sedia un po’ torvo e quando lei gli dice che ci saranno a tavola anche i signori Ianniello la prende male, gli stanno antipatici tutti e due. Ecco, da un lato la soddisfazione che a lei manca da parte del marito; dall’altro il fastidio con cui lui nasconde la gelosia crescente che prova per quel vicino, il ragioniere Ianniello, così prodigo di attenzioni eccessive per sua moglie.
Riassunto così c’è qualcosa di fuori misura in questo farsesco dramma familiare suscitato da un piatto di maccheroni alla siciliana, conditi col pomodoro fresco e le melanzane fritte, che lui Peppino Priore aveva molto gradito a casa di Maria Carolina, la nuora, provocando una dispettosa ritorsione da parte di lei Rosa Priore. Qualcosa di surreale potremmo dire, sarà la suggestione di quelle sette portefinestre che si aprono su altrettanti balconi lungo un arco di cerchio che circoscrive lo spazio domestico dell’azione e sembrano dipinte su un cielo rannuvolato che dà un’impronta magrittiana all’immagine. Tutte spalancate all’inizio, occupate dagli attori disposti a coppie in posa statuaria. Quando entra, lui chiude tutte le imposte, prima di sedersi a sfogliare il giornale. E questo apri e chiudi si ripeterà più volte nel corso dello spettacolo a sottolineare anche lo sviluppo meteorologico dei tre atti.
È un testo datato, Sabato, domenica e lunedì. Nel senso proprio di legato in maniera indissolubile a quel momento storico. Siamo nel 1959, al culmine del boom economico che cambierà il paese, l’Italia si prepara alle Olimpiadi che ci saranno l’anno dopo insieme alla rivolta popolare che non aveva digerito il tentativo di riportare indietro le lancette politiche del paese. Dieci anni dopo, in un contesto ormai del tutto mutato, ancora si cantavano i “morti di Reggio Emilia”. Si chiudono in quel momento quegli anni Cinquanta che molti ricordano tristi e democristiani ma che forse meriterebbero un qualche ripensamento.
Qualcuno, mi pare di ricordare, cercò di anticipare di qualche decennio l’ambientazione della commedia. Ma non funzionò. Non può funzionare senza quel “compratevi il Gattopardo” di zia Memè (l’impeccabile Anita Bartolucci) che condensa una ancora confusa volontà contestataria e quasi femminista. Senza quella aspirazione della più giovane a diventare annunciatrice televisiva che preannuncia l’emergere di nuovi costumi sociali. Ed è assolutamente straordinario come un testo radicato in un preciso momento storico, riesca a parlarci in maniera quasi rabdomantica di quel che poi è diventato il paese nostro e di come sia successo. Quella di cui parla è una realtà, umana familiare e sociale, che ci pare di conoscere bene, che in qualche modo ci appartiene. Questa piccola borghesia egoista e sentimentale che assapora il primo benessere economico e il primo confuso desiderio di acculturazione, il salto di classe dalla Fiat seicento alla millecento, fa parte del nostro dna nazionale, del nostro “album di famiglia”.
Ma si diceva della lettura che fa De Fusco di Sabato, domenica e lunedì, così puntigliosamente opposta a quella di Servillo e Bonaiuto. C’è però un momento in cui i due lavori sembrano incontrarsi, nella percezione dello spettatore. Succede nel terzo atto, quando cade per un attimo la maschera della commedia e bisogna inventarsi una faticosa riconciliazione. Lei, la sofferente Teresa Saponangelo, sta abbandonata in vestaglia nella poltrona, nella finzione di un malore di cui tutti si guardano bene di dubitare, bisogna dire che l’ha passata brutta, se no si piglia collera. Lui, Claudio Di Palma, dopo essersi umiliato davanti a tutti per la mattana del giorno prima, si è seduto accanto a lei e recita a sua volta la parte che gli hanno insegnato i figli, rinunciando alle sottolineature che fin lì hanno divertito la platea. È allora che allo spettatore può capitare di riconoscere, imprevedibilmente, quel momento di commozione che si era vissuto tanti anni fa, proprio a quel punto dello spettacolo di Toni Servillo. Come la memoria involontaria di qualcosa che riemerge. Viene in mente la “piccole frase” musicale della sonata di Vinteuil che nella Recherche proustiana Swann ascolta nel salotto dei Verdurin e da cui rimane colpito in maniera straordinaria, ricordando di averla già ascoltata in passato. Qualcosa dai contorni imprecisati, che ha la durata di un istante e nel quale tuttavia ci si riconosce. Sarà per un saperli e sentirli appartenere a quel nostro “album di famiglia” che non riusciamo a voler male a Rosa e Peppino Priore, che quel loro dolore rimosso ci tocca fin quasi alle lacrime. Si scannano per un piatto di maccheroni alla siciliana, sappiamo che si tratta di ben altro. Forse il senso da dare alle loro vite.
© Gianni Manzella