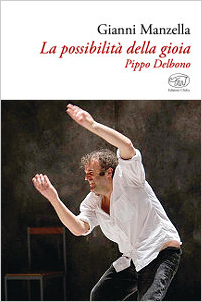-
Heiner Müller, Guerra senza battaglia
L’insegna circolare del Berliner Ensemble in alto sul cielo di Mitte, il quartiere centrale dell’antica capitale tedesca, era l’ultima immagine a cui guardava indietro chi attraversava l’innaturale confine fra le due parti della città divisa. Lasciandosi alle spalle il museo di Pergamo e quel mondo un po’ irreale di strade silenziose e pulite, in cui si muovevano poche macchine di un unico modello. Era l’estate del 1989. Ma ecco che proprio lì, su quel confine, una diversa immagine si sovrapponeva all’altra, in un inevitabile corto circuito emotivo. Erano le lacrime di chi restava di là, sul cui valore politico non ci si poteva ingannare. “Il muro sarà in piedi anche fra cinquanta o cento anni”, aveva affermato Honecker all’inizio dell’anno. Avrebbe resistito solo pochi mesi, prima di essere sbriciolato in souvenir turistico. E le Trabant dai tenui colori pastello le avremmo poi viste sciamare come in una festa al di là della frontiera.
 In quegli stessi giorni d’estate, in un teatro di Amburgo si poteva assistere alla messinscena del primo testo scritto trent’anni prima da Heiner Müller, Der Lohndrucker, realizzata al Deutsches Theater di Berlino est dallo stesso autore, in uno stile ecletticamente spettacolare che da una chiave espressionista inclinava verso tentazioni sperimentali alla Robert Wilson. Senza incontrare particolari censure, segno che qualche maglia si allentava anche nel burocratico regime tedesco orientale, pur sospettosissimo in fatto di glasnost e perestroika, le due parole magiche dell’epoca a est di quel che, attingendo a una impropria metafora teatrale, ancora si chiamava sipario di ferro. Müller era del resto già considerato, e da tempo, il più importante autore teatrale tedesco contemporaneo. Rappresentato su tutti i palcoscenici internazionali e premiato con tardivi riconoscimenti anche nella Ddr. Si era garantito il privilegio di stare con un piede di qua e uno di là dal muro, come diceva di sé: o più politicamente: su entrambi i lati della barricata, con le parole di un personaggio del suo Hamletmaschine.
In quegli stessi giorni d’estate, in un teatro di Amburgo si poteva assistere alla messinscena del primo testo scritto trent’anni prima da Heiner Müller, Der Lohndrucker, realizzata al Deutsches Theater di Berlino est dallo stesso autore, in uno stile ecletticamente spettacolare che da una chiave espressionista inclinava verso tentazioni sperimentali alla Robert Wilson. Senza incontrare particolari censure, segno che qualche maglia si allentava anche nel burocratico regime tedesco orientale, pur sospettosissimo in fatto di glasnost e perestroika, le due parole magiche dell’epoca a est di quel che, attingendo a una impropria metafora teatrale, ancora si chiamava sipario di ferro. Müller era del resto già considerato, e da tempo, il più importante autore teatrale tedesco contemporaneo. Rappresentato su tutti i palcoscenici internazionali e premiato con tardivi riconoscimenti anche nella Ddr. Si era garantito il privilegio di stare con un piede di qua e uno di là dal muro, come diceva di sé: o più politicamente: su entrambi i lati della barricata, con le parole di un personaggio del suo Hamletmaschine.Più interessante, in quel 1989, poteva apparire il risalire indietro nel tempo, ai testi che affrontavano le contraddizioni in cui si era costruito il cosiddetto socialismo reale, per lo spettatore occidentale che di Heiner Müller conosceva soprattutto la produzione più recente e in lui vedeva un compagno di strada del presente. Una spia della lacerazione del mondo contemporaneo. Che di questa lacerazione, anzi, aveva fatto il cardine della sua scrittura, con la quale replicava i temi e i testi della classicità, dall’antichità di Medea e Filottete al Settecento delle Liaisons dangereuses, quasi a voler affermare l’impossibilità creativa del (e nel) presente. Erede e continuatore di Brecht, dichiaratamente: persino con un pizzico di civetteria, nel mimare i “drammi didattici” del maestro di Augusta. Ma senza più illusioni, facendo anzi di questa disillusione una bandiera.
Lo stakanovista, recita la traduzione di Der Lohndrucker – ma non rende il tono assai meno benevolo del termine originale: più o meno, colui che comprime il salario. Il protagonista della pièce è infatti una sorta di eroe del lavoro, modellato sulla figura reale di un muratore che con la sua brigata era stato capace di riparare un forno industriale in metà del tempo previsto. Suscitando forse l’entusiasmo delle gerarchie ma non quello dei compagni di lavoro, anche perché accompagnato da sospetti di delazione. Quando Müller aveva cominciato a scrivere il dramma non era lontana la rivolta berlinese del 1953, iniziata proprio sull’onda della protesta operaia per l’aggravarsi delle condizioni di lavoro. E avrebbe poi coinciso con la costruzione del muro, nel 1961, la proibizione di mettere in scena la pièce successiva, Die Umsiedlerin, La contadina sfollata, in cui affrontava la collettivizzazione dell’agricoltura nella Ddr. In quel momento sull’autore non si abbatte solo la censura, è una vera e propria proscrizione. Müller viene espulso dall’Unione degli scrittori; su istigazione di Helene Weigel, si forza a scrivere un’autocritica che a distanza di tempo non gli provoca sussulti morali. Sopravvivere come artista è la sua priorità. Ma seguono anni di vita precaria, e i suoi testi subiranno da lì in poi un costante interdetto.
Una vita sotto due dittature, recita il sottotitolo di Guerra senza battaglia (Zandonai, pp. 370, € 26,00), autobiografia in forma di intervista uscita originariamente nel 1992. A quindici anni dalla morte del drammaturgo, leggere queste pagine discontinue rituffa dentro un’epoca che sembra più lontana dei decenni che ce ne separano, tanto è forte il legame con la storia che vi si riflette. Il fatto è che la vita artistica di Heiner Müller coincide per intero con quella della Ddr, tanto che la scomparsa di questa lo porterà a una impasse creativa senza sbocchi. L’esperienza del nazismo e poi della guerra e dell’occupazione sovietica, vissuta in maniera anche drammatica negli anni dell’adolescenza, sono il terreno di coltura in cui matura la scelta di schierarsi dalla parte della nascente “repubblica degli operai e dei contadini”. Non seguirà il padre, vecchio militante socialista, che all’inizio degli anni cinquanta era fuggito a ovest con la moglie e il fratello. Non mostra ripensamenti nemmeno dopo, quando si fa evidente il fallimento di quell’utopia, non avendovi nutrito fede. L’aver fatto esperienza di quel fallimento diventa al contrario il motore della sua scrittura. Tutto è materia di dramma, e solo questo conta.
C’è di mezzo il paradosso dichiarato che per scrivere una dittatura è più stimolante di una democrazia. Shakespeare sarebbe impensabile in una democrazia, afferma. E c’è il conforto della vicenda brechtiana, il suo districarsi fra fedeltà e dissenso, il fatto che a Berlino est restava il suo teatro, anche se dopo la morte di Brecht il Berliner Ensemble era diventato una sorta di mausoleo. Con un’ironia e uno straniamento davvero brechtiani, Müller si racconta dentro un vortice di burocrati ottusi, di intellettuali opportunisti, di teatranti in lotta per un posto di potere. Con momenti di irresistibile divertimento, come quando descrive le visite a funzionari di grado sempre più elevato fino ad arrivare a Honecker (all’epoca non ancora capo dello stato ma responsabile del settore sicurezza) perché gli sia consentito di sposare una cittadina bulgara, cosa impossibile senza espressa autorizzazione. Oscillando fra memorie pubbliche e private, verrebbe da dire. Ma quale privato può mai darsi in una società in cui tutti si sanno spiati – e tutti possono essere sospettati di aver collaborato con la Stasi. Quasi inevitabile pensare a Le vite degli altri, anche per l’ambientazione teatrale del film. Ma varrebbe piuttosto la pena di andare a rileggersi quel libro spietatamente bello e dimenticato che è Il suonatore di tango di Cristoph Hein (pubblicato nel 1989, alle coincidenze della storia non si sfugge!).
La Ddr è stata un sogno che la storia ha trasformato in un incubo, scrive Heiner Müller. E torna in mente lo sguardo alla “rovine d’Europa” con cui si apre Hamletmaschine, enigmatico viaggio in mezzo a fantasmi personali e collettivi che però, nelle sue poche pagine, si rivela anche una sfida rivolta dall’autore a chi fa teatro. È a questo incrocio fra autoritratto collettivo e ricerca di teatralità che il drammaturgo tedesco ha combattuto la sua personalissima guerra. Come dice un personaggio del suo Quartett: recitare? che altro si può fare?
Articoli correlati