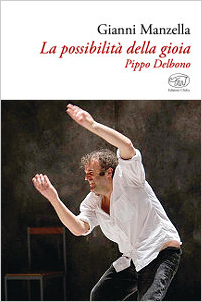-
L’abisso del visivo, Zapruder e il prisma dell’immagine
Dopo l’anteprima alla scorsa Biennale Cinema di Venezia e il debutto al festival Sterischer Herbst a Graz, Chiavi in Mano, progetto cinematografico installativo della formazione Zapruder Filmmakersgroup, è approdato a Bologna, nella cornice delle attività di Xing. Il lavoro di Zapruder ormai da diversi anni si colloca in quella zona interstiziale fra arti visive, performative e interventi cinematografici ed è il risultato di una commistione tra tecnologia e artigianato che indaga in modo originale la storia delle tecniche di visione, in un processo di continua messa in discussione del linguaggio, delle estetiche e dei dispositivi tecnici.

Chiavi in mano (2010) è un dittico composto da due nuclei complementari e autonomi, il film stereoscopico in 3D All Inclusive e Joule, un ambiente stereo audiovisivo. Si tratta di lavori indipendenti ma essi intrattengono una relazione sottile, quasi impercettibile, fatta di rimandi interni che si instaurano sia a livello dell’immaginario quanto nella tessitura dei loro ritmi: la gestione costruttivista del tempo e della materia di cui è fatta l’immagine. Più che di un dittico, allora, sarebbe meglio parlare di una struttura prismatica, dato l’intreccio profondo che li lega. Torneremo, tuttavia, in seguito su questa connessione interna.
All Inclusive è organizzato su un doppio piano visivo e sonoro: bianco e nero per l’immagine; una texture di fondo e alcune melodie per l’ambiente sonoro. Questo lungometraggio parla del lavoro, del suo sacrificio, di quei casi clinici definiti Work addicted: il primo lungometraggio del duo composto da David Zamagni e Nadia Ranocchi è dunque una messa in scena delle conseguenze del lavoro, delle degenerazioni di una identità appiattita su di esso, di un equilibrio fragile sempre pronto a spezzarsi entro il set di un albergo geometricamente kubrickiano.
Questa la cornice di fondo; tuttavia si tratta di una cornice inclinata che lascia trasparire una fessura che ci fa segno, che ci chiama. Come spiegare quest’impressione?
Il film parte dalla fine, svela l’evento. Allora l’evento, almeno quello visibile, non è il centro del film. O meglio, fedeli a una tradizione di spaesamento costante delle aspettative della visione, Zapruder sembrano dirci: questo non è (solo) un film. Ma, piuttosto, è una trappola per l’occhio. La dimensione scopica di questo lavoro non è quella della visione ma sembra dimorare nel suo contrappunto sonoro. L’evento, nel film, sembra costruito sul suono.
Riprendiamo la considerazione iniziale: la tessitura di questo film è consegnata, apparentemente, all’immagine. Ma forse non è esattamente così. Perché?
È questione di tempo, della sua (presunta) linearità. Certo, il tempo è lineare nel senso che ci consegna una storia in cui una giovane direttrice di un hotel arriva, s’installa nelle sue mansioni quotidiane e uccide, uno per volta, gli altri colleghi dell’hotel, proprietario compreso. (Si sa, qualcuno sopravvive sempre, però… la moglie del proprietario, per esempio, fantasma senza voce, forse specchio invecchiato della protagonista …).
Tuttavia ciò che interessa rispetto al filo del tempo è che l’epilogo è dato, in realtà, in apertura del film; è sbattuto in primo piano e consegnato a una magistrale immagine di soffocamento (tecnicamente un’icona in bianco/nero): grazie al trattamento in 3D, la testa nella plastica che viene soffocata dalle mani della ragazza sembra la nostra, forse il respiro affannato di quell’uomo è il nostro, lo si sente addosso come una sfocatura. Ecco la trappola all’opera. Il dispositivo è già in funzione. Siamo in trappola dentro un sistema che ci fa vedere una cosa ma ne dice un’altra.
Se la trama del film è svelata dalla prima immagine, significa che, dichiaratamente, la tensione del film è svuotata attraverso un meccanismo di anticipazione: allora l’immagine, questa immagine, è un acceleratore della fine, letteralmente. Ci invita a guardare (sic!) altrove: precisamente dentro l’orecchio.
Detta così, dalla parte dell’occhio, questo film sembrerebbe un’operazione fallita, una noia (visiva) che si dispiega. Tutt’altro. A ben guardare – o forse non è tanto questione qui di guardare quanto più radicalmente di vedere in profondità (scopicamente, appunto) dentro il pulviscolo di questa noia che invece rivela oggetti, dettagli, gesti, spazi, respiri che si stagliano tridimensionalmente nella cornice dell’inquadratura grazie alla sapienza compositiva delle scena e del movimento degli attori.La linearità del tempo si sviluppa allora sulla direttrice sottile di una piega che fa cambiare il piano alle cose. Ci sono delle crepe, dei sintomi, che segnalano e accompagnano questo cambio di registro. L’immagine prosegue inesorabile verso il suo compimento mentre il suono che ci avvolge proviene, con una leggera sfasatura, dai dettagli che sbalzano dal tessuto noioso dell’immagine per innestare l’orecchio nell’occhio e inscrivervi così l’evento: si tratta qui, radicalmente, di guardare con le orecchie. Il cortocircuito è giunto a compimento: là dove l’immagine accelera, dilatandosi oltremodo e senza cesure verso la fine, al suono spetta la tessitura della trama, il contro-senso del film, la sua tensione magnetica (o magmatica) che apre una breccia dentro la consolazione dell’immagine per installarvi la tensione degli eventi.
Senza scomodare Hitchcock e Lynch, siamo comunque di fronte a un cinema (da camera) per le orecchie. Il suono sembra essere il detentore occulto dell’abisso dell’immagine; il suono come contro-immagine, il suo contrappunto ineluttabile: la carica atmosferica che l’attraversa. Il film arriva, la sua tensione ci attraversa, e si imprime in modo subliminale nel corpo dello spettatore a occhio morto; in una sorta di dépense – nel senso batailliano caro a Zapruder – dello sguardo.
È solo in questa sospensione che può dispiegarsi Joule, l’altra faccia del prisma. L’altro punto di penetrazione (o forse sarebbe meglio dire di emersione) scopica: l’esplosione del tema di fondo che corre in All Incusive. Non è un caso che quest’ambiente stereo audiovisivo porti il nome – Joule appunto – dell’hotel di All Inclusive. Si tratta in altri termini di una scheggia che isola e dilata, secondo un ribaltamento del piano, le componenti della struttura portante del lungometraggio cui fa riferimento. Ci fa vedere quello che non è dato nel primo. È il suo punto-luce, il suo spazio di colore, la sua temperatura: frammentato e inquietante, tendenzialmente anti-narrativo. Joule è il contro-tempo di All Inclusive, la sua fibrillazione.Chiavi in mano è, allora, prima di tutto un’indagine sulle andature del tempo dell’immagine: il tempo-deserto di All Inclusive che procede senza fratture ritmiche, senza misura, in cui l’immagine emerge per sedimentazione dilatandosi a perdifiato; oppure il tempo metrico di Joule in cui l’immagine affiora invece per fratture, sbalzi, sequenze ritmiche.
È qui che il prisma composto da Zapruder con Chiavi in mano rivela l’immagine che apre sull’abisso per richiudersi sulla percezione: là dove l’occhio diviene orecchio e viceversa, incessantemente.