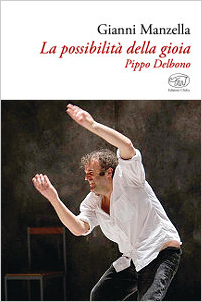-
Una partita tra la finzione e la realtà. Una conversazione con Tadeusz Kantor
“Ci sono molte difficoltà impreviste. Lo spettacolo non è ancora finito. E poiché in qualche modo devo sempre cavarmela in una situazione – nella vita ho avuto molte situazioni difficili – allora anche ora me la sono cavata, da stamattina proprio. Lei ne è stato testimone. Infatti mi sono fatto una domanda stupida: se tutti gli elementi dello spettacolo devono essere rifiniti. Allora mi sono risposto che no. Ho notato durante le prove, ed era una cosa molto importante, che riescono meglio di tutte quelle scene collettive che sono arrangiate in modo spontaneo, dove io intervengo direttamente e in quel momento invento, trovo soluzioni per la situazione e la metto su. Sono le situazioni più vive. Poi ho commesso un errore: quelle azioni spontanee e quei momenti più essenziali, quel momento dove qualcosa si è scoperto, che sono sempre nascosti in una normale opera d’arte, questi sono appunto i momenti più interessanti. Quindi ho deciso, un po’ costretto dalla necessità, perché la prima si avvicina, ma sappiamo che la necessità è madre delle migliori invenzioni. Allora ho pensato che l’ultima scena, la più essenziale – che è l’‘Ultima cena’ – di improvvisarla. Un’unica cosa sarà falsificata, cioè io reciterò quel momento in cui quella cosa mi è entrata in testa, questo veramente lo devo recitare. Credo però che riuscirò a farlo in modo tale che la gente penserà che la sto improvvisando, perché si tratta del fatto che il pubblico deve credere che io ho avuto quell’idea lì per lì, che non ho avuta un’altra soluzione, perché la cosa più difficile è sempre l’ ‘Ultima cena’. Tutti sono ormai annoiati e aspettano per alzarsi. E poi la cosa si svolge in un modo spontaneo, io dirigerò soltanto i movimenti degli attori, affinché non si uccidano a vicenda, che non si feriscano, perché ci sarà una confusione, una folla enorme. E difenderò il pubblico dall’aggressione degli attori. Allora avete già il materiale…”
Ha sentito allora delle costrizioni, in questa esperienza a Firenze, nell’avere delle scadenze, nel dover per forza fornire uno spettacolo?
Avevo premesso, questo era un mio presupposto, di non sentire questo, questa costrizione. Avevo scritto perfino un saggio intitolato L’opera e il processo. Del resto è una tendenza nota negli ultimi anni, per esempio nelle arti plastiche, dove il prodotto, l’opera finita, viene sostituito dal processo stesso. E questo si chiama appunto ‘process art’. Ma io personalmente, malgrado che fossi uno dei primi che ha iniziato questa tendenza, ho notato che gli artisti che esercitano la cosiddetta ‘process art’ in realtà non scoprono, non rivelano affatto il processo, la creazione. In realtà danno un prodotto finito, ma il processo stesso è falsificato, perché è praticamente impossibile dimostrare il processo della creazione, si dovrebbe distruggere il concetto stesso dell’opera. Ciò non di meno il teatro è un’istituzione dove questo si può mostrare, proprio perché l’azione teatrale è un processo, non è un’opera pronta. E’ quasi un’opera effimera. Prima della ‘process art’ c’è la tendenza dell’arte effimera, io stesso facevo manifestazioni di questo genere, dove l’opera in realtà non c’era oppure dove quest’opera veniva da me distrutta. A che cosa tendo? Che il teatro è quel territorio dove si può in modo molto efficace dimostrare il processo senza quella premessa, che sto facendo appunto un’opera d’arte. Da me c’è sempre questa tendenza, io non avevo premesso che farò uno spettacolo nuovo. All’inizio quando mi accingevo all’attività, non avevo ancora un fondamento, una base testuale. Questa base di testo si creava nel processo, e di fatto questa base qui non c’è, non la si può rintracciare. Quindi per me non si trattava di creare uno spettacolo ma di provare, di vedere se le mie idee è possibile visualizzarle e ottenere contemporaneamente una ricezione del pubblico. Si tratta quindi delle idee non dell’opera. In realtà in fondo questo spettacolo non ha il limite di un’opera, non ha né inizio né fine. Ogni scena finisce in modo tale che si potrebbe dire che è già la fine, non c’è quel concetto che ogni scena inizia e finisce. Non ci sono quindi indirizzi e confini di un’opera d’arte. E’ una nube impregnata di certe idee, non è però un’opera d’arte questa, è una piramide.
L’assenza di un testo, è anche l’assenza di un autore, qui la base testuale nasce dalla sua esperienza. Ciò dipende da un suo attuale bisogno o dalla sfiducia nel rappresentare qualsiasi testo scritto?
Ci sono più momenti che bisogna sottolineare. Prima di tutto non è tanto questione di fiducia o sfiducia. Ritengo che la letteratura drammatica è un malinteso, cioè la letteratura drammatica è oggigiorno scritta – e questo è cominciato già nell’Ottocento, e dura in realtà fino a oggi. Esiste autonomamente, chiaramente con questa riserva: che ogni autore ha la speranza e la pretesa che la cosa verrà poi rappresentata in un teatro. Nessuno di questi autori, che basterebbe soltanto leggerla. Ripeto quello che ho già detto una volta, benché possa sembrare un po’ scioccante, che ho scelto i testi di Witkiewicz per molto tempo perché i testi di Witkiewicz sono soltanto per leggere e non per rappresentare. E’ assolutamente non vero quello che molti dicono, che i testi di Witkiewicz sono ottimi da recitare. Ne è prova, e questo è molto importante, che tutti i tentativi di tutti i registi in tutto il mondo di rappresentare Witkiewicz sono falliti. Tutte le pièces che conosco, rappresentate in diversi teatri, sono fatte, rappresentate in modo tremendo. Non è Witkiewicz. Perché tutti ne fanno una farsa e invece non è una farsa. Witkiewicz non può essere rappresentato, non lo si può recitare, è impossibile, perché è semplicemente un discorso intellettuale. La cosa migliore è che alcune persone si mettessero a tavola e cominciasse questo grande discorso assurdo, tutta questa confusione di filosofia, estetica, politica e di lui stesso. E’ interessante, curioso che tutti gli spettacoli di Witkiewicz, tutti i suoi drammi, sono scritti come per una registrazione di tutti questi grandi baccanali che succedevano a casa sua. E questi incontri che lui faceva a casa sua, dove si incontravano le persone più intelligenti della Polonia di allora, le donne più belle, dove si usufruiva di vari narcotici, il che poi pare non sia vero, perché Witkiewicz nel momento in cui tutto questo succedeva intorno a lui, sedeva in mezzo e beveva birra e dipingeva. Erano ‘séances’ di artisti, e durante ciascuna di queste lui era capace di fare una decina di ritratti. In realtà le messinscene di Witkiewicz dovrebbero svolgersi in questo modo, attorno a un tavolo dove si beve, dove si mangia bene e dove si parla in un modo fantastico di arte, di filosofia. Più o meno su questo principio io avevo fatto la Gallinella acquatica dove tutto si svolge a un grande tavolo. Pare che, secondo i relitti dei testimoni, in quella casa succedessero diversi scandali, perfino tentativi di suicidio. Questo è il problema del testo. Se prendevo i testi di Witkiewicz allora non rappresentavo, non recitavo i testi di Witkiewicz ma recitavamo ‘con’ Witkiewicz – in inglese ‘to play with’. Per finire, che io nego al teatro la funzione di illustrare, di riprodurre, di interpretare qualcosa che esiste al di fuori del teatro, di qualcosa che è stato costruito prima. Non è lingua verbale. Io invece creo il teatro che ha un proprio linguaggio, che non è un linguaggio verbale, è un linguaggio che non si può tradurre in nessun altro linguaggio. Qualsiasi genere di sceneggiatura, che scrivo dopo, è infedele perché fedele è soltanto lo spettacolo e questo spettacolo non può essere spiegato. Possiamo solo parlare a tavola su temi filosofici estetici politici ma non su questo spettacolo perché lo spettacolo si deve vedere, percepire. In Wielopole Wielopole c’è anche un altro problema, che non si tratta dell’importanza del testo ma quello che ha importanza é il linguaggio verbale, la parola, e questo elemento deve esistere nel teatro. Senza questo il teatro è o pantomima o balletto. Deve esistere perché è il segno più umano dell’intelligenza umana. In questo spettacolo il linguaggio verbale c’è, ho fatto di tutto per privarlo della stilistica letteraria, dando agli attori questo genere di compito: la famiglia è concentrata intorno al morto e in modo veramente scandaloso litiga per l’eredità. Sette persone, ognuna delle quali deve pronunciare alcune frasi, perché si deve dare l’impressione di un litigio, di uno scambio di frasi. Allora chiedevo agli attori che ognuno a modo suo trovasse delle frasi che fossero le più correnti, le più di luogo comune. Cancellavamo tutte quelle frasi che non avevano quella forza del linguaggio quotidiano, l’espressione del più banale, però sono quelle che cadono più facilmente dentro l’orecchio. Chiaramente è in polacco, però lo pronunciamo in modo tale che si sente l’intenzione della frase. Qualche volta facciamo che qualche frase particolarmente riuscita la traduciamo nella lingua di quel paese dove siamo, per segnalare semplicemente di cosa si tratta. Però di testi non ce ne sono poi tanti.
Quello che volevo dire è un po’ diverso. Si nota un progressivo andare dal ‘play with’ altri autori al ‘play with’ se stesso. Mi sembra un fatto molto grosso che un autore metta in scena direttamente se stesso.
In questo spettacolo, perché ancora nella Classe morta c’era Witkiewicz, non gioco soltanto con me stesso ma anche con personaggi che io stesso ho rievocato. Sono personaggi tutti morti, se fossero vivi credo che si sarebbero offesi a morte perché tutta la mia tendenza andava verso non una illustrazione o una rappresentazione ma verso una falsificazione, perché soltanto attraverso una falsificazione e attraverso una mistificazione si evita questo grande pericolo, dell’illustrazione e della rappresentazione. Per questo di tutti questi personaggi della mia famiglia sono in questo spettacolo i bassi sociali, i personaggi del rango più basso. Queste persone potrebbero accusarmi se fossero vive. Contemporaneamente c’è anche un ‘play with’ alcune idee, perché non le illustro, perché se le illustrassi queste idee, allora potrebbero essere o contro di me o pro, invece qui gioco con la religione, con il vangelo, con l’esercito, con il concetto della società, qui è la mia famiglia. In realtà non gioco questa partita fino in fondo, non è possibile, non voglio affatto essere il vincitore ma naturalmente non lascio neppure vincere loro. E’ soltanto appunto una partita. C’è sempre mistificazione, falsificazione, però attraverso questo io ottengo una cosa molto importante: la verità nell’arte.
Che ruolo occupa la religione nel suo teatro e in questo spettacolo, anche in relazione al ruolo che occupa nella cultura polacca? Il villaggio dove è nato era stretto fra la chiesa cattolica e la sinagoga ebraica…
Io non mi esprimo, non mi pronuncio sull’argomento della religione. Non mi pronuncio sui temi politici e su quello dell’esercito. Persino quando si presenta un personaggio che potrei dire che è Himmler, non voglio pronunciare questa parola. Dico: quel signore. Perché nel momento in cui dicessi un hitleriano, tradirei tutto il terrore, il contenuto terrificante. Sempre ciò che è terrificante è nascosto, non è visibile. Noi sentiamo soltanto che è dietro i fatti reali… Per me è molto importante… la paura. Allora dico: quel signore. E’ incognito, è travestito, perché è molto facile fare i personaggi hitleriani. Allora questo dà l’impressione della paura. Qui è una povera zia pazza che si è travestita da Himmler. Questo dà veramente un terrore terribile. Io non posso rappresentare Cristo, non può servire la croce. Dico: questo oggetto importante. Non posso dire Golgota, dico: oggetto detto Golgota. Perché sarebbe estremamente facile rappresentare il Cristo che porta la croce. La mia attitudine verso la religione non deve importare a nessuno. Invece il ruolo della religione nella vita sociale, senza giudicare la religione, è estremamente importante. Se io qui ho toccato il tema della religione e del vangelo, l’ho fatto perché nella mia infanzia, per sette anni, avevo confidenza con la chiesa, quasi ci abitavo, così come avevo confidenza con la sinagoga attraverso molti amici ebrei. Quindi questa questione della religione, che io non posso essere pro o contro come artista, posso solo esporla o ritirarla. E bisogna dire che ogni opera d’arte grande, e tutti abbiamo la pretesa di fare una grande opera d’arte, è molto vicina alla religione, è quasi la stessa sfera. Se invece si tratta del Papa, chiaramente questa notizia (della presenza alla prima di Wielopole) era tutta composta, non proveniva da me. Devo dire però onestamente che ero veramente rimasto impressionato, e un’impressione del genere non l’avevo mai ricevuta, quando il Papa è stato in Polonia. La ricezione, parlo con una terminologia teatrale, è imparagonabile con il teatro. Il teatro non otterrà mai una cosa del genere, perché era un uomo solo che, sia grazie alla tradizione di duemila anni sia tramite la propria personalità, attirava milioni di persone.
Il tema della morte compare costantemente nei suoi spettacoli. Cos’è per lei la morte?
Il concetto della morte non è connesso solo alla religione, è connesso a ogni uomo. La religione crea soltanto un’ottima piattaforma sulla quale l’uomo concepisce la morte, sulla quale l’uomo si abitua alla morte. Il concetto della morte è invece estremamente attirante per l’arte perché è indefinito, è inesperito, non ne abbiamo esperienza, perché nel momento stesso in cui uno ne fa esperienza è già morto. Quindi è l’unico fenomeno che è indefinito, impossibile a recepire e che però esiste sempre, costantemente. Quindi è un oggetto da cui tutta l’arte dall’inizio della sua esistenza è stata affascinata. L’arte non ha voluto risolvere questo problema, perché è impossibile, ma questo problema e questo argomento è il più affascinante della nostra cultura. Chiaramente per l’arte, perché l’arte si occupa di cose impossibili, che sono al di là della nostra esperienza. Per questo si può dire che l’arte è trascendentale e per questo si avvicina alla religione.
Cosa intende per ‘realtà del rango più basso’ di cui ha parlato?
Si tratta della realtà, cioè di un concetto che è contrario alla finzione. Devo però subito sottolineare che il concetto della realtà io lo considero come un concetto che non può esistere da solo, senza il concetto della finzione. Siamo quindi su un livello un po’ superiore rispetto ai miei avi della prima avanguardia. Cioè la prima avanguardia proprio rifiutava la finzione, creava l’oggetto concreto. Questo oggi ormai è naif, è ingenuo. La realtà può esistere soltanto se contemporaneamente tocchiamo in un qualche senso il concetto della finzione. Quindi per esempio questo spettacolo è in fondo una continua partita fra la finzione e la realtà, perché il ricordo è la finzione. Prima per me la finzione era il testo letterario, attualmente è il ricordo. Ma il ricordo lo devo rievocare attraverso la realtà, non attraverso gli stati psichici, cioè a un certo punto l’attore recita lo stato di ricordarsi, no, recita realmente, attraverso e con l’aiuto di oggetti reali. Ma questi rapporti fra l’oggetto e l’attore sono dello stesso genere come nel ricordo, cioè non ci ricordiamo ‘tutto’ l’oggetto, ci ricordiamo solo una parte. Io mi ricordo mio padre, per esempio, non come un insieme, un tutto-un-padre, ma probabilmente siccome ero piccolo me lo ricordo come gli stivali gialli. E qui mio padre si presenta parzialmente, perché entra e comincia a buttare ingiurie. E’ tornato dalla caserma e voleva così imporsi alla famiglia, con il suo atteggiamento brutale e mio padre, che poi appunto resta un personaggio del rango più basso, della ‘ditta di noleggio dei personaggi’, non ne ho fatto un eroe che si è preso una medaglia durante la guerra ma è un semplice disertore che per di più si comporta tremendamente, butta il peggior tipo di ingiurie. Questa è la realtà, cioè non rappresenta niente, lui esce soltanto e dice le parolacce, nulla di più. La realtà quindi è un oggetto o una situazione o uno stato psichico che non ha le pretese di illustrare delle situazioni, stati o oggetti preesistenti ma è di sé, a sé stante in questo spazio e in questo tempo, non imita nulla.
In questo interesse per i personaggi di rango più basso c’è anche una concezione della storia?
Una concezione della storia? No, è piuttosto una concezione estetico-filosofica, cioè esiste una certa filosofia dell’oggetto, che l’oggetto ottiene la sua materialità e la sua realtà nel senso puro nel momento in cui perde la sua utilità. Allora non è più utile dal punto di vista pratico e può diventare utilità artistica. Cioè questo oggetto dal punto di vista della vita deve essere sulla soglia della consumazione, della distruzione, oppure ormai completamente distrutto, cioè alla soglia della pattumiera, dell’immondezzaio. Per questo in un mio manifesto avevo detto che l’oggetto buttato nell’immondezzaio si trova sulla soglia dell’eternità, tra l’immondezzaio e l’eternità. Questo ritorna alla data del 1960 e vorrei sottolineare, e forse ritorna ancora di più al 1944 quando facevo Il ritorno di Ulisse, il Teatro clandestino. Lì nacque questa idea della realtà di rango più basso, cioè l’oggetto più povero, quasi buttato nell’immondezzaio. E’ un certo tipo di concetto estetico, vale la pena di ricordare la scuola italiana dell’arte povera, che appunto è comparsa negli anni Sessanta. Per questo dico che questa data è importante. Io poi apprezzo molto l’arte povera, non era per me un modello, però avevo trovato che era molto affine a quello che facevo io. Piuttosto la cosa è rivolta contro il cosiddetto teatro povero.
Cosa ne pensa del teatro povero?
E’ il mio teatro che è teatro povero. Nel ’44, nel ’61, queste sono appunto le prime date, perché tra il ’44 e il ’61 c’è questo tempo di silenzio, di silenzio politico.
Quali sono le tappe fondamentali della sua ricerca artistica?
Tutti i caratteri di sviluppo del Teatro Cricot 2 si contengono già nel Teatro clandestino che è durato dal ’42 al ’44. ’55 è la fondazione del Cricot e le prime manifestazioni. ’61 è il Teatro informale, è la prima tappa definita, il riallacciamento al Teatro clandestino, cioè la realtà del rango più basso, cioè la realtà povera; questo è connesso anche alla pittura, all’arte informale. ’63 si prende le conseguenze più spinte dell’arte informale, cioè il Teatro zero, cioè il gioco, la recitazione con il vuoto, con il nulla. ’67 c’è la tappa del Teatro di happening, dopo molti miei happening in Polonia e in Europa, una specie di conclusione di tutto questo, perché sempre la tappa successiva è un trarre le conclusioni da quella precedente. Allora ’72 Teatro impossibile e ’75 Teatro della morte. Per quanto riguarda questa tappa non ho ancora il nome.
Lei ha fatto scenografia, pittura, happening, oltre che il teatro. Qual è il rapporto tra tutte queste forme artistiche?
Non c’è nessun rapporto. Il rapporto ci potrebbe essere se dicessimo che ciascuna di queste attività ha un’altra struttura materiale. Invece io non faccio differenze tra la mia attività teatrale e quella plastica, figurativa o di tipo ‘environment’, perché non è essenziale per me la questione di forma materiale che chiude. Per me la questione essenziale è quella delle idee ma non di tipo filosofico, di tipo diverso, altro. Di un tipo cioè che non è possibile, non può essere espresso in un linguaggio filosofico né letterario ma appunto in questo territorio che è tra il teatro e le arti visive.
Che cos’è l’avanguardia?
Avanguardia è avanguardia. Il concetto di avanguardia come sappiamo è stato è stato fondato a cavallo di due secoli ma esisteva già prima. Questa parola non è stata usata… Benvenuto Cellini anche lui era una avanguardia perché era largamente combattuto. Credo che la stessa cosa debba avvenire per molti altri poeti e scrittori rinascimentali. In fin dei conti anche i romantici erano un’avanguardia nell’Ottocento, gli impressionisti erano un’avanguardia, i cubisti pure. Ogni arte che cambia è un’avanguardia. Soltanto questo concetto è stato sfortunatamente ridotto a un certo periodo di tempo, cioè se parliamo dell’avanguardia si parla sempre di questa avanguardia dei primi del Novecento. Ma è un concetto in realtà abbastanza costante, eterno proprio perché tutto cambia. E se cambia allora è già avanguardia. Però non bisogna confondere la cosa col concetto della marcia e dell’esercito, perché è preso dal linguaggio militare, avanguardia e retroguardia. Qui non si va in avanti, perché non c’è né avanti né dietro ma si cambia. In quale direzione chi lo sa, mi posso voltare attorno al mio asse, e già il mostrare invece che la mia faccia il mio dietro già può essere scioccante. Quindi è una questione del mutamento, non del marciare in avanti.
La conversazione è stata registrata a Firenze nel giugno 1980, durante le prove di Wielopole Wielopole, e pubblicata nel numero 7 di “art’o”, ottobre 2000.