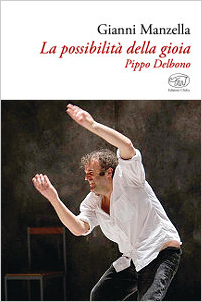-
Dilatando il futuro. A proposito di Nowhere di Marino Formenti
C’è una piccola casa di legno, con tante finestre. Dentro c’è un uomo, occupato a suonare un pianoforte, seduto accanto al tronco di un albero, che è al centro della piccola casa, come un pilastro. L’uomo è concentrato, silenzioso, attento. Non c’è niente di rituale in quello che fa: suona come fa ogni giorno, da anni probabilmente, dal momento che è un pianista.
La sua pratica di musicista è posta nella piccola casa ed è così esposta, ma senza alcun esibizionismo, senza traccia di virtuosismo. Pare che Mario Formenti non sia ospitato con il proprio progetto all’interno del festival Foreign Affairs presso il Berliner Festspiele (una versione della performance dedicata a John Cage era stata proposta nella primavera scorsa a Bologna, per Live Arts Week): è lui, piuttosto, a ospitare tutti coloro che entrano all’interno della casa, ad accoglierli – senza alcun gesto di esplicita ospitalità – all’interno di quello spazio e, così, del proprio tempo. Ogni giorno, per tre settimane, il pianista ha suonato nella piccola casa nell’arco di dodici ore, dalle 11 del mattino alle 11 di sera. In quel lasso di tempo era possibile entrare nella casa e prendere posto su uno dei materassi e cuscini sistemati sul pavimento, attorno al piano e perfino sotto di esso. In quelle ore, era anche possibile entrare nella casetta da lontano, per così dire, guardando in streaming la scena ripresa da una telecamera fissa posizionata sopra il pianoforte e trasmessa in tempo reale sul sito del festival.
Era così possibile ascoltare Formenti suonare il repertorio da lui prescelto – prevalentemente pezzi di Cage, Feldman, Couperin e Satie – in un ordine sparso, privo di razionalità: i pezzi si ripetevano, venivano troncati, tornavano a risuonare nello spazio della giornata, nello spazio della casa. In qualsiasi momento il pianista poteva decidere di smettere di suonare, adagiarsi su uno dei materassi come uno spettatore qualunque. Ogni giorno comunque, per dodici ore la scena della sua pratica era allestita e offerta in dono a un pubblico inatteso, non pagante.
Riflettendo su quale sia la dimensione politica della performance, su quale sia il suo potenziale critico come agente di una trasformazione politica ad ampio spettro, un’idea si fa strada: tale potenziale, se è esiste, è situato al di fuori di ogni politica della rappresentazione. Esso ha a che fare, piuttosto, con l’idea di lavoro e con la preziosa opportunità di riconfigurare il suo modo di produzione. Ha a che fare con il privilegio che ha la performance di avere a che fare con il tempo come materia prima del proprio operare e al contempo come strumento di una possibile battaglia in un più ampio orizzonte di trasformazione politica, cioè di azione all’interno di una polis. In un celebre passaggio de L’autore come produttore, Walter Benjamin rifletteva così sulla responsabilità che ogni gesto artistico rivoluzionario trattiene rispetto all’apparato che lo ospita in termini produttivi: “trasmettere l’apparato di produzione senza trasformarlo, per quanto possibile, è una procedura altamente discutibile, anche quando il contenuto dell’apparato che viene trasmesso sembra essere di natura rivoluzionario. […] L’apparato di produzione borghese riesce ad assimilare un numero incredibile di temi rivoluzionari e propagarli senza mettere seriamente in questione la propria esistenza”.
Nel contesto del neoliberismo e della sua ricaduta in termini di organizzazione del lavoro, tale capacità di assimilazione dell’apparato di produzione artistica sembra essere ulteriormente potenziata: in tale contesto infatti, la logica secondo cui il lavoro artistico avviene è prevalentemente quella del ‘progetto’ – inteso come un’unita di lavoro la cui articolazione si basa da un lato sul sacrificio, da parte del lavoratore, del proprio tempo libero (il tempo durante il quale il ‘progetto’ viene concepito e presentato poi per ricevere finanziamenti ad hoc, non considerato, se non retrospettivamente, come ‘tempo lavoro’) e dall’altro su un’ipoteca sul futuro (il tempo in cui il progetto avverrà, se finanziato, un tempo-lavoro limitato a una potenziale, ridotta unità di produzione rispetto al quadro più ampio di concezione e azione che ha condotto il progetto a raggiungere la sua forma). In questa logica, non è casuale che sempre più spesso, nel corso degli ultimi decenni, gli artisti abbiano scelto di presentare al pubblico il proprio lavoro in termini di work-in-progress, secondo una prassi che sembra rispondere a esigenze di poetica e di verifica, ma più spesso ha a che fare con la precisa necessità di accedere a modalità di produzione (benché limitate) senza abdicare a uno sviluppo di più ampio respiro del lavoro. In questo quadro, sembra che all’artista/lavoratore venga implicitamente chiesto di adottare una logica del tutto simile a quella su cui ruota il capitalismo finanziario: la logica dell’investimento. La retribuzione cioè è subordinata a un momento successivo a quello in cui il lavoro avviene, come se il lavoro fosse tale, in realtà, sono nel momento in cui la ‘produzione artistica’ non solo entrerà in circolazione, ma acquisirà valore di scambio e infine genererà plus-valore. Come se la ‘produzione artistica’ non fosse invece il frutto di un lavoro, che avviene in un certo tempo e in certo spazio, spesso al di fuori o precedentemente a una catena di valutazione.
Come osservava Paolo Virno ne La Grammatica della moltitudine, la figura del performer – la cui produzione non esiste al di fuori della prassi che la genera, del processo che è al contempo prodotto del suo lavoro – è in un certo senso paradigmatica della direzione in cui il lavoratore intellettuale esiste all’interno della logica del post-fordismo: dal momento che il tempo lavoro della performance coincide di fatto con il tempo di vita del performer, esso è esposto a divenire potenzialità interamente sfruttabile. All’interno di tale logica, ne consegue che per portare avanti la propria pratica artistica come lavoro, l’artista è costretto a farsi impresario della propria soggettività, organizzando dunque il proprio lavoro secondo una temporalità non autonoma, bensì indotta: non solo il tempo della concezione di un progetto, ma anche quello della pratica artistica sono subordinati a un calendario di scadenze per la richiesta di finanziamenti; successivamente, ai tempi e ritmi ‘dati’ per l’esecuzione del progetto, che spesso coincidono, nella proiezione incessante verso un futuro di possibili opportunità, con l’articolazione di altri progetti.
Rispetto a questo scenario, la questione centrale su cui si confronta qualsiasi tentativo di articolare un’alternativa politica a tale modo di produzione, sembra risiedere in strategie di riappropriazione tattica dell’orizzonte del proprio futuro, sfuggendo così alla logica di investimento che sembra perfettamente funzionale a reiterare l’apparato di produzione dato. O in altre parole, nella possibilità di immaginare una temporalità autonoma del proprio tempo lavoro, un ritmo che, nel momento stesso in cui abita la temporalità indotta di tale logica produttiva, riesce a stabilire al contempo la propria alterità – e così facendo possa operare una trazione sull’orizzonte del futuro – quello del proprio lavoro e, possibilmente, quello di chi lo incontra.
Con questo pensiero in mente voglio tornare a considerare Marino Formenti nella sua piccola casa di legno (progettata per Foreign Affairs da Kyohei Sakaguchi), posizionata nel giardino del Berliner Festspiele per tre settimane all’interno di un festival, come ‘progetto’ con un inizio e una fine sì, eppure decisamente, sottilmente sovversivo rispetto alla stessa logica che gli permette di esistere come ‘progetto’. Marino Formenti suonava senza fretta, all’interno della casa, senza urgenza di presentare il proprio lavoro nella forma di un’opera, senza necessità di rendere la propria pratica ‘evento’. Suonava ogni giorno per un tempo più lungo di quello che generalmente si può concedere, dal momento che opera a livello internazionale come pianista e conduttore d’orchestra – e dunque oltre lo specifico della propria prassi artistica immagino si confronti con una moltitudine di dettagli tecnici e organizzativi del proprio lavoro. Dettagli che intrinsecamente, al di là della posizione più o meno affermata di un artista e dunque della continuità dei propri ingaggi, interrompono la temporalità autonoma di sviluppo della sua pratica.
Nello spazio della casa di legno, per tre settimane Marino Formenti si è concesso dodici ore al giorno per sperimentare una misura specifica per il proprio lavoro, una temporalità priva di urgenze. Si è costruito una cornice all’interno del quale provare un modus operandi fuori dalle urgenze del presente. Il tempo senza fretta della sua concentrazione si è fatto così forma spaziale all’interno della quale era possibile entrare, come spettatori, accedendo non solo al prodotto di un lavoro artistico – l’impegno costante e continuato di un artista alle prese con il proprio strumento – ma anche a un pensiero su ciò che un lavoro artistico può essere. Questo pensiero ha a che fare con la resistenza che il tempo della concentrazione potrebbe costituire rispetto al tempo banale della sopravvivenza, in una possibile strategia di sovversione degli spazi e tempi dati dall’apparato di produzione, ma elaborata dal suo interno, trasformandone così la logica. E’ forse per questo che al termine di ogni pezzo suonato, Marino Formenti si alzava dal pianoforte e scriveva con un gessetto il titolo del brano eseguito e l’orario in cui lo aveva eseguito, andando a coprire, nell’arco delle tre settimane, l’intera superficie delle pareti della piccola casa come una seconda pelle. La scrittura cioè componeva uno spartito del lavoro offerto al pubblico, segnando lo spazio di un tempo riterritorializzato, occupato, come innestando un diverso fuso orario rispetto a quello del presente.
In questo tempo divenuto scena, spazio di ospitalità, per gli spettatori era possibile incontrare ‘l’evento’ della musica eseguita, ma non attenderlo. L’evento non era offerto nella sua eccezionalità irripetibile, né come prodotto per cui un biglietto può essere acquistato e a cui può corrispondere una specifica qualità di attenzione spettatoriale. L’evento era consegnato all’accidente dell’incontro, nella durata di una tecnica eccellente, ma che concepiva al suo interno anche la stanchezza, l’imperfezione, il tentativo. Non si trattava, cioè, di un work-in-progress, non per lo meno se con questo termine s’intende un’unita di lavoro appositamente fermata (come tappa) per essere condivisa con un pubblico. Si trattava piuttosto di assistere a un lavoro in continuità, latore di una propria durata, all’interno della forma data dal ‘progetto’: un lavoro che poteva soffemarsi e ruotare su se stesso, nella ripetizione – come l’ultima sera, in cui Formenti ritornava quasi ossessivamente a suonare un pezzo di Satie, ogni volta in toni diversi, con diversi accenti, diversi affetti, quasi a interrogare il brano e la sua stessa pratica nel gioco di questa ripetizione.
Uscendo dalla casetta in cui Formenti suonava, il tempo sembrava dilatato, potenzialmente scomposto nel suo scorrere banale. Il tempo trascorso all’interno della casa perdurava come affetto e l’impressione che si aveva era di essere precisamente affetti dalla possibilità di questo tempo autonomo per il proprio lavoro. Non è forse un caso, allora, che il progetto di Formenti fosse intitolato Nowhere, letteralmente ‘nessun luogo’ e dunque u-topos. L’agire utopico, scriveva Bloch molti anni fa, ha la prerogativa di operare una trazione sul tempo futuro, a partire dal presente: è oggi il momento in cui si immagina un altro tempo e nel mentre lo si immagina, lo si abita già. Almeno per un po’, occupando il tempo come zona temporaneamente autonoma, progetto per progetto, dilatando il futuro.
Articoli correlati