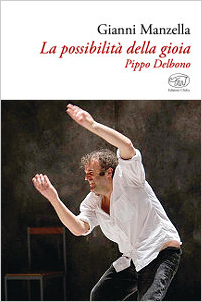-
Constanza Macras, un altrove chiamato Berlino
Questo non è uno spettacolo su Berlino. Dicono così le parole proiettate in apertura sullo schermo di fondo, nelle quattro lingue della città divisa in settori negli anni postbellici. Come fossero anch’esse poste su un confine, per entrare in questo Berlin Elsewhere, in questo altrove a cui solo provvisoriamente possiamo dare il nome di Berlino. E viene in mente quel dipinto di Magritte, caro ai semiologi, che sotto l’immagine di una grande pipa reca la didascalia “ceci n’est pas une pipe”. Per dire di uno scollamento tra immagine e realtà, tra l’identità dell’oggetto e la sua rappresentazione (si intitola non a caso L’uso della parola) su cui si è esercitata tanta arte del Novecento.
Siamo di nuovo in viaggio, verso questo altrove, insieme a Constanza Macras. La coreografa argentina (lei però preferisce definirsi soltanto porteňa) sa come mettere in danza la globalizzazione dell’immaginario. Non per gusto postmoderno, malgrado l’innato eclettismo o la voracità con cui addenta ogni immagine. Ma perché così va il mondo, lo dice già la sua biografia di argentina fuggita ad Amsterdam e New York per studiare danza e ora stabilita a Berlino con la sua compagnia Dorky Park. In Scratch Neukölln ci aveva portato in un popolare quartiere berlinese, approdo di immigrati rivisitato di recente come Hell on heart con i suoi ragazzini campioni di street dance. E naturalmente lo strepitoso Big in Bombay portava forte l’odore dell’India, con quei corali movimenti coreografici che citavano spudoratamente il cinema di Bollywood. Fino al viaggio più perturbante, nella tropicale foresta di No Wonder in cui l’artefice aveva scelto di rimettersi in gioco impudicamente in prima persona, per un corpo a corpo con i fantasmi del suo paese. E poi ancora il paradiso artificiale di Brickland dove una comunità agiata replicava i suoi riti sociali e le sue pratiche sportive a confronto più recente Megalopolis, titolo di per sé esplicativo di un mondo globalizzato in cui non ci si conosce più.
Di cosa parla allora Berlin Elsewhere? Di caffè Starbuks e di controlli agli aeroporti. Di come affrontare un colloquio di lavoro. Di crisi di panico all’Ikea. Di orsetti di gelatina e scarpe firmate e mezzo mondo che muore di fame. Di un tipico appartamento di Berlino Est, dove ancora si sente l’odore del freddo che esce dalla stufa a carbone. Di politica sessuale. Di cosa significa oggi in Germania il concetto di olocausto. Della violazione delle regole come sintomo della malattia mentale. Dei sogni che tutti si portano dietro. C’è il danzatore che viene da una favela nei pressi di Rio, in Brasile, per il quale la realtà imita i cliché. E c’è quella che sogna il giorno in cui tutti i paesi parleranno coreano. Quella che prima non c’era nulla da comprare e ora non ci sono i soldi per comprare. E quella che li va interrogando, con tutti i cliché del caso appunto (bevono perché sono poveri o sono poveri perché bevono?), in cui con imbarazzo un po’ ci riconosciamo. Poveri, vagabondi e teste pazze… Immigrati vietnamiti, giovani palestinesi, prigionieri politici argentini…
C’è come sempre un tema all’origine di uno spettacolo di Constanza Macras, o forse meglio una meta da raggiungere. E lo spettacolo non è allora che il percorso da compiere per riempire questa distanza, o la somma dei detriti che ogni storia si lascia dietro (la memoria è fragile, l’immondizia resta per sempre – è il suo motto). In Berlin Elsewhere il punto di partenza è il tema della follia, della segregazione come meccanismo di controllo sociale. Partendo dalla classica Storia della follia nell’età classica di Michel Foucault, che già prendeva le mossa dai lebbrosari del medioevo per dire di folli, eretici e criminali, la drammaturgia firmata da Carmen Mehnert guarda a poveri, vagabondi e teste pazze, per coniugare la figura dell’escluso nel mondo contemporaneo, di coloro che assumono la parte scomparsa del lebbroso.
Ma qui bisogna fermarsi, non è il partito preso o l’ideologia politicamente corretta che ci fa grande il teatro di Constanza Macras. Bisogna vederlo, questo spettacolo. Bisogna esserci, qui al Palamostre di Udine dove il Css festeggia la trentesima stagione di Teatro Contatto. Faccia a faccia con questi straordinari danzatori, bizzarri come vuole la sigla della compagnia, sanno fare di tutto e poco cambia se muta un poco ogni volta la composizione dell’ensemble (invano cerchiamo la bionda americana Jill Emerson, volto e corpo in cui si era identificato il teatro di Constanza Macras, però c’è una Fernanda Farah di una bravura ugualmente mostruosa). Ciò che Macras ci pone davanti è come d’abitudine un universo assai caotico, anche se di un caos ben temperato si tratta. In mezzo a sagome di palazzoni che simulano, in materiale espanso, quelli che trascorrono sullo schermo, fra cieli nuvolosi e scale mobili che si protendono verso l’invisibile (sarà il sogno di Giacobbe?), e crollano e vengono rimessi in piedi, si dipana la “confusione” orchestrata dalla coreografa, il suo gusto divertito e divertente per le commistioni pasticciate, il suo indisciplinato giocare a cavallo dei generi, ma anche un severo bisogno etico di “tornare al presente”, come suggeriva il titolo del suo primo successo. La polifonia gestuale con cui persegue la dissoluzione della danza. La sfida di danzare continuando a parlare o viceversa, negli improvvisi cambi di ritmo dettati dai musicisti che da un lato alternano silenzi a un rockjazz assai ritmato. Con immagini memorabili come la casa antropomorfa che sarebbe stata bene in una pièce di Copi, altro trasfuga argentino dopo tutto. O la pedana gonfiabile che d’improvviso invade la scena, zattera della Medusa o nave dei folli che da Bosch mena a Erasmo, in cui qualcuno può riconoscere la forma curvilinea del cinema Universum di Mendelsohn diventato sede della nuova Schaubühne – e farà naufragio mentre i corpi avvinghiati degli interpreti si esercitano in una orgiastica dialettica. Senza smettere di divertirsi moltissimo, e di divertirci non meno, Constanza Macras è fra i pochi artisti in grado di porre il problema del posizionamento dell’artista, ma anche dello spettatore, nei confronti della realtà contemporanea.
Articoli correlati